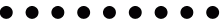un racconto di Claudio Santacroce
 Da ragazzino trascorrevo gran parte delle vacanze nella cascina di mia nonna materna, ai margini di un paesino situato in cima ad una collina del Monferrato. Erano lunghe estati sfrenate e selvagge, senza le regole cittadine da rispettare, a parte la svogliatissima e veloce compilazione dei maledetti compiti delle vacanze ai quali, per la verità, mi dedicavo solo nei quindici giorni precedenti il ritorno a scuola. Eravamo una bella banda: io, i miei cugini più o meno lontani che abitavano nella cascina e nei dintorni, i figli di altri villeggianti provenienti da Torino e addirittura da Genova. Mi ricordo di Gigi, Bruno, Roberto, Stefano, Loris, Tullio, Piero, Dante e le sue sorelle gemelle Laura e Beatrice (i genitori erano entrambi professori di lettere al Liceo Classico!), Patrizia, Maria Teresa, ecc. Noi maschi ci dedicavamo alle nostre occupazioni preferite: organizzavamo avventurose esplorazione nelle vigne e nei boschi dei dintorni, andavamo a maròda di frutta, giocavamo al pallone, costruivamo una capanna con legni e materiali di recupero, in un luogo nascosto per evitare che le bande nemiche ce lo distruggessero, e qui ci ritiravamo per interi pomeriggi a fare merenda con pane, burro e marmellata e a costruire archi, frecce, lance, spade e bombe di terra. Giocavamo ai cow boy e agli indiani, o alla guerra in genere, mentre, quando pioveva, ci rinchiudevamo nella stalla a disputare infinite partite a Monòpoli. Allora le femmine ci interessavano pochissimo, anzi niente, erano un peso, un ingombro anche se loro si offrivano di interpretare il ruolo di combattive squaw e di volenterose vivandiere. Accettavamo, spesso a malincuore, di portarcele dietro, ma sovente gliela facevamo pagare sottoponendole a scherzi schifosi a base di lucertole e rospi. Poi un giorno mia nonna morì e da allora andammo a villeggiare in montagna. Al paese materno tornavamo solo per visitare le tombe dei nostri morti o per i funerali di qualche parente. Passarono così una quindicina d’anni. Ma quell’anno mio padre, che non aveva potuto salire in paese per la ricorrenza dei morti, decise che ci saremmo andati per la festa patronale di San Martino, l’11 novembre. “Passiamo al cimitero, poi assistiamo alla Messa grande, alla fine salutiamo i parenti e poi andiamo alla Corona Grossa a mangiarci due cannelloni e un bel fritto misto”, programmò mio padre, come sempre in ogni particolare. La mattina del fatidico giorno, ci vestimmo tutti e tre eleganti come avessimo dovuto recarci a un matrimonio. Io avevo il mio nuovo abito invernale, giacca, camicia, cravatta alla moda, scarpe di cuoio lucidissime. Profumo di lavanda ben distribuito nei posti giusti. Arrivati in paese, parcheggiata l’auto, ci avviammo a piedi alla piazza della chiesa. Mio padre notò subito che in un angolo era stato allestito un grande capannone, evidentemente per ospitare il ballo pubblico. Ci avvicinammo e scoprimmo che per mezzogiorno la Pro Loco avava organizzato una grande bagna cauda. “Cosa ne dite se ci fermassimo a mangiare qui? È una vita che non assaggio una bagna cauda come si deve. E poi magari troviamo qualche vecchio amico per fare una rimpatriata”. Mia madre acconsentì pur facendo notare che il giorno dopo, lui in ufficio e io all’università, tutti avrebbero immediatamente capito che avevamo mangiato dell’aglio. A me andava tutto bene, anzi mi sarei divertito ad alitare in faccia a qualche delicato compagno. La Messa andò per le lunghe, seguì la processione. Al termine, i miei si fermarono a salutare parenti e amici. Io incontrai qualche cugino; una cugina era incinta; seppi che qualcuno era andato via dal paese in cerca di un lavoro sicuro, stufo di fare il contadino. Finalmente ci avviammo al capannone. Dentro non c’era riscaldamento: il calore, mi informarono, sarebbe derivato dalla presenza umana e dalle laute libagioni. Eravamo tra i primi arrivati. Pagammo la quota. Non c’erano posti prestabiliti e, potendo scegliere, ci sedemmo al fondo di uno dei chilometrici tavoli approntati dagli organizzatori per qualche centinaio di persone. La gente incominciava ad arrivare e a occupare i posti. Quelli davanti a noi erano ancora liberi quando si avvicinarono marito, moglie e due ragazze che si assomigliavano in maniera stupefacente: due gemelle evidentemente. Non le riconobbi, ma conobbi subito i loro genitori, i signori Bonino, quelli che affittavano la villetta vicino alla cascina della nonna, quando ero ragazzino. Con i miei furono subito saluti, strette di mano, esclamazioni di sorpresa, complimenti “Sedetevi qui con noi, così parliamo un po’ dei bei tempi” li invitò mio padre. Così fecero e io mi trovai con le due ragazze davanti. In effetti ero rimasto quasi senza parole: Laura e Beatrice erano proprio carine e simpatiche. Chi lo avrebbe mai detto, ricordavo benissimo quelle due piccole smorfiosette e scocciatrici che cercavano sempre d’infilarsi nei nostri giochi di maschi, che appena le sfioravi, incominciavano a strillare come galline a cui si sta tirando il collo. E sì, il tempo era passato e le due gemelle adesso erano dei veri bocconcini! Intanto gli inservienti avevano incominciato a versare la bagna cauda dentro a terrine personali per ogni commensale, con sotto la meta accesa per scaldarli. Sul tavolo c’erano grossi grilletti con tutte le verdure di stagione da intingere: cardi gobbi di Nizza, topinambour, patate e cavolfiori bolliti, barbabietole, peperoni arrostiti, sedani, cipolle, cavoli, cuori d’insalata e altro ancora. E poi per ognuno c’era un piatto di fettine di carne cruda tagliata finissima e una bottiglia di vino novello. All’inizio tutti si buttarono all’arrembaggio sulla bagna cauda con la stessa velocità con la quale partono le Formula Uno. Per un po’ nessuno disse più niente impegnato a ingurgitare tutto il possibile con la voracità e la golosità di un coccodrillo a digiuno. Poi, pian piano, qualcuno incominciò a dare i primi sintomi di affaticamento, anzi di riempimento, e a rallentare i bocconi e la conversazione prese a farsi sempre più fluida e vivace, certo stimolata dai bicchieri di vino che si andavano consumando. Io però non avevo mai smesso di osservare le due ragazze. Anzi, lo confesso, avevo avuto un classico colpo di fulmine e mi ero innamorato di loro. Sì, proprio di tutte due, si assomigliavano così tanto che non avrei saputo quale scegliere. Oltre tutto, parlando, avevo capito che, incredibilmente, non avevano il ragazzo. Forse a scoraggiare i pretendenti era proprio la loro somiglianza, che impediva, come a me, di scegliere l’una o l’altra. In effetti a me andavano bene entrambe e, visto come stavano le cose, qualche speranza di successo con loro potevo averla. In mezzo a un rumore assordante, in un capannone ormai surriscaldato, la grande bagna cauda si stava intanto trascinando verso la conclusione, tenuta viva solo dai soliti spiritosi che, per scommessa, avevano deciso di non mollare e raccattavano, dai tavoli già abbandonati, gli avanzi rimasti delle verdure e della bagna sempre meno cauda. A quel punto apparve all’entrata del capannone un mio vecchio amico del paese, Marco, che si guardava attorno per vedere chi c’era. Gli feci cenno con una mano, lo chiamai al nostro tavolo. Venne in qua e riconobbe subito tutti. Salutò i nostri genitori e me, abbracciò con vigore e baciò con effusione le due gemelle. “Avete finito? Allora che ne dite se andassimo a berci un bel caffè al Bar Centrale?” Non aspettò neppure una risposta, prese sotto braccio Beatrice, che era la più a tiro, e si diresse verso l’uscita. Anch’io e Laura ci avviammo verso il fondo del tavolo, e alla fine mi accostai alla ragazza e, a mia volta, la presi amichevolmente sotto braccio. Andammo al bar, sempre chiacchierando e ricordando le avventure di una volta e informandoci sulle nostre attuali occupazioni. Bevemmo un caffè, poi un altro, visto che il gusto dell’aglio incominciava a manifestarsi, poi tentammo con un gelato e infine con un digestivo. Marco ci assecondava, anche se lui la bagna cauda non l’aveva mangiata e quindi non aveva problemi. Come di regola, però, il gusto d’aglio persisteva, nonostante ogni tentativo di occultamento, accompagnandosi perdipiù a una leggera nausea, conseguenza della faticosa digestione. Intanto era venuto l’ora che, coi genitori, avevamo fissato per il ritorno. Ci avviammo verso il parcheggio. Davanti Marco e Beatrice, un po’ più indietro Laura ed io. Le stradine del paese erano deserte, erano tutti chiusi nel capannone, nel frattempo adibito a balera. Rallentai il passo lasciando che gli altri due andassero più avanti e quando fummo a una curva della strada, col cuore che batteva a mille, strinsi più vicino a me Laura. Non oppose alcuna resistenza, anzi. Allora approfittando dell’oscurità di un androne aperto, la spinsi in un angolo e la baciai. Non fu insensibile, anzi. Il bacio andò per le lunghe, finché lei si staccò e mi disse “Basta adesso, cosa penseranno quei due se non ci vedono arrivare?” Così ci svincolammo e affrettammo il passo fino a raggiungerli. Ci accorgemmo subito che tra loro non era capitato nulla, anzi dalla distanza che Marco teneva da Beatrice intuimmo che doveva esserci stato qualche problema d’intesa. Non sto a raccontare il resto della giornata. Sta di fatto che, dopo quell’incontro, io e Laura incominciammo a frequentarci anche in città e tre anni dopo, finita l’università e trovato un impiego, ci sposammo. Questa storia, per me a lieto fine, ha una sua evidente morale: se vuoi baciare una ragazza, nonostante tu abbia l’alito pesante a causa dell’aglio, è fondamentale, anzi è assolutamente obbligatorio, che pure lei abbia mangiato la bagna cauda… Ovviamente la regola vale anche a parti invertite, come può testimoniare mia cognata Beatrice che da quella volta, a scanso di equivoci, rinunciò, purtroppo per lei, a mangiare la bagna cauda.
Da ragazzino trascorrevo gran parte delle vacanze nella cascina di mia nonna materna, ai margini di un paesino situato in cima ad una collina del Monferrato. Erano lunghe estati sfrenate e selvagge, senza le regole cittadine da rispettare, a parte la svogliatissima e veloce compilazione dei maledetti compiti delle vacanze ai quali, per la verità, mi dedicavo solo nei quindici giorni precedenti il ritorno a scuola. Eravamo una bella banda: io, i miei cugini più o meno lontani che abitavano nella cascina e nei dintorni, i figli di altri villeggianti provenienti da Torino e addirittura da Genova. Mi ricordo di Gigi, Bruno, Roberto, Stefano, Loris, Tullio, Piero, Dante e le sue sorelle gemelle Laura e Beatrice (i genitori erano entrambi professori di lettere al Liceo Classico!), Patrizia, Maria Teresa, ecc. Noi maschi ci dedicavamo alle nostre occupazioni preferite: organizzavamo avventurose esplorazione nelle vigne e nei boschi dei dintorni, andavamo a maròda di frutta, giocavamo al pallone, costruivamo una capanna con legni e materiali di recupero, in un luogo nascosto per evitare che le bande nemiche ce lo distruggessero, e qui ci ritiravamo per interi pomeriggi a fare merenda con pane, burro e marmellata e a costruire archi, frecce, lance, spade e bombe di terra. Giocavamo ai cow boy e agli indiani, o alla guerra in genere, mentre, quando pioveva, ci rinchiudevamo nella stalla a disputare infinite partite a Monòpoli. Allora le femmine ci interessavano pochissimo, anzi niente, erano un peso, un ingombro anche se loro si offrivano di interpretare il ruolo di combattive squaw e di volenterose vivandiere. Accettavamo, spesso a malincuore, di portarcele dietro, ma sovente gliela facevamo pagare sottoponendole a scherzi schifosi a base di lucertole e rospi. Poi un giorno mia nonna morì e da allora andammo a villeggiare in montagna. Al paese materno tornavamo solo per visitare le tombe dei nostri morti o per i funerali di qualche parente. Passarono così una quindicina d’anni. Ma quell’anno mio padre, che non aveva potuto salire in paese per la ricorrenza dei morti, decise che ci saremmo andati per la festa patronale di San Martino, l’11 novembre. “Passiamo al cimitero, poi assistiamo alla Messa grande, alla fine salutiamo i parenti e poi andiamo alla Corona Grossa a mangiarci due cannelloni e un bel fritto misto”, programmò mio padre, come sempre in ogni particolare. La mattina del fatidico giorno, ci vestimmo tutti e tre eleganti come avessimo dovuto recarci a un matrimonio. Io avevo il mio nuovo abito invernale, giacca, camicia, cravatta alla moda, scarpe di cuoio lucidissime. Profumo di lavanda ben distribuito nei posti giusti. Arrivati in paese, parcheggiata l’auto, ci avviammo a piedi alla piazza della chiesa. Mio padre notò subito che in un angolo era stato allestito un grande capannone, evidentemente per ospitare il ballo pubblico. Ci avvicinammo e scoprimmo che per mezzogiorno la Pro Loco avava organizzato una grande bagna cauda. “Cosa ne dite se ci fermassimo a mangiare qui? È una vita che non assaggio una bagna cauda come si deve. E poi magari troviamo qualche vecchio amico per fare una rimpatriata”. Mia madre acconsentì pur facendo notare che il giorno dopo, lui in ufficio e io all’università, tutti avrebbero immediatamente capito che avevamo mangiato dell’aglio. A me andava tutto bene, anzi mi sarei divertito ad alitare in faccia a qualche delicato compagno. La Messa andò per le lunghe, seguì la processione. Al termine, i miei si fermarono a salutare parenti e amici. Io incontrai qualche cugino; una cugina era incinta; seppi che qualcuno era andato via dal paese in cerca di un lavoro sicuro, stufo di fare il contadino. Finalmente ci avviammo al capannone. Dentro non c’era riscaldamento: il calore, mi informarono, sarebbe derivato dalla presenza umana e dalle laute libagioni. Eravamo tra i primi arrivati. Pagammo la quota. Non c’erano posti prestabiliti e, potendo scegliere, ci sedemmo al fondo di uno dei chilometrici tavoli approntati dagli organizzatori per qualche centinaio di persone. La gente incominciava ad arrivare e a occupare i posti. Quelli davanti a noi erano ancora liberi quando si avvicinarono marito, moglie e due ragazze che si assomigliavano in maniera stupefacente: due gemelle evidentemente. Non le riconobbi, ma conobbi subito i loro genitori, i signori Bonino, quelli che affittavano la villetta vicino alla cascina della nonna, quando ero ragazzino. Con i miei furono subito saluti, strette di mano, esclamazioni di sorpresa, complimenti “Sedetevi qui con noi, così parliamo un po’ dei bei tempi” li invitò mio padre. Così fecero e io mi trovai con le due ragazze davanti. In effetti ero rimasto quasi senza parole: Laura e Beatrice erano proprio carine e simpatiche. Chi lo avrebbe mai detto, ricordavo benissimo quelle due piccole smorfiosette e scocciatrici che cercavano sempre d’infilarsi nei nostri giochi di maschi, che appena le sfioravi, incominciavano a strillare come galline a cui si sta tirando il collo. E sì, il tempo era passato e le due gemelle adesso erano dei veri bocconcini! Intanto gli inservienti avevano incominciato a versare la bagna cauda dentro a terrine personali per ogni commensale, con sotto la meta accesa per scaldarli. Sul tavolo c’erano grossi grilletti con tutte le verdure di stagione da intingere: cardi gobbi di Nizza, topinambour, patate e cavolfiori bolliti, barbabietole, peperoni arrostiti, sedani, cipolle, cavoli, cuori d’insalata e altro ancora. E poi per ognuno c’era un piatto di fettine di carne cruda tagliata finissima e una bottiglia di vino novello. All’inizio tutti si buttarono all’arrembaggio sulla bagna cauda con la stessa velocità con la quale partono le Formula Uno. Per un po’ nessuno disse più niente impegnato a ingurgitare tutto il possibile con la voracità e la golosità di un coccodrillo a digiuno. Poi, pian piano, qualcuno incominciò a dare i primi sintomi di affaticamento, anzi di riempimento, e a rallentare i bocconi e la conversazione prese a farsi sempre più fluida e vivace, certo stimolata dai bicchieri di vino che si andavano consumando. Io però non avevo mai smesso di osservare le due ragazze. Anzi, lo confesso, avevo avuto un classico colpo di fulmine e mi ero innamorato di loro. Sì, proprio di tutte due, si assomigliavano così tanto che non avrei saputo quale scegliere. Oltre tutto, parlando, avevo capito che, incredibilmente, non avevano il ragazzo. Forse a scoraggiare i pretendenti era proprio la loro somiglianza, che impediva, come a me, di scegliere l’una o l’altra. In effetti a me andavano bene entrambe e, visto come stavano le cose, qualche speranza di successo con loro potevo averla. In mezzo a un rumore assordante, in un capannone ormai surriscaldato, la grande bagna cauda si stava intanto trascinando verso la conclusione, tenuta viva solo dai soliti spiritosi che, per scommessa, avevano deciso di non mollare e raccattavano, dai tavoli già abbandonati, gli avanzi rimasti delle verdure e della bagna sempre meno cauda. A quel punto apparve all’entrata del capannone un mio vecchio amico del paese, Marco, che si guardava attorno per vedere chi c’era. Gli feci cenno con una mano, lo chiamai al nostro tavolo. Venne in qua e riconobbe subito tutti. Salutò i nostri genitori e me, abbracciò con vigore e baciò con effusione le due gemelle. “Avete finito? Allora che ne dite se andassimo a berci un bel caffè al Bar Centrale?” Non aspettò neppure una risposta, prese sotto braccio Beatrice, che era la più a tiro, e si diresse verso l’uscita. Anch’io e Laura ci avviammo verso il fondo del tavolo, e alla fine mi accostai alla ragazza e, a mia volta, la presi amichevolmente sotto braccio. Andammo al bar, sempre chiacchierando e ricordando le avventure di una volta e informandoci sulle nostre attuali occupazioni. Bevemmo un caffè, poi un altro, visto che il gusto dell’aglio incominciava a manifestarsi, poi tentammo con un gelato e infine con un digestivo. Marco ci assecondava, anche se lui la bagna cauda non l’aveva mangiata e quindi non aveva problemi. Come di regola, però, il gusto d’aglio persisteva, nonostante ogni tentativo di occultamento, accompagnandosi perdipiù a una leggera nausea, conseguenza della faticosa digestione. Intanto era venuto l’ora che, coi genitori, avevamo fissato per il ritorno. Ci avviammo verso il parcheggio. Davanti Marco e Beatrice, un po’ più indietro Laura ed io. Le stradine del paese erano deserte, erano tutti chiusi nel capannone, nel frattempo adibito a balera. Rallentai il passo lasciando che gli altri due andassero più avanti e quando fummo a una curva della strada, col cuore che batteva a mille, strinsi più vicino a me Laura. Non oppose alcuna resistenza, anzi. Allora approfittando dell’oscurità di un androne aperto, la spinsi in un angolo e la baciai. Non fu insensibile, anzi. Il bacio andò per le lunghe, finché lei si staccò e mi disse “Basta adesso, cosa penseranno quei due se non ci vedono arrivare?” Così ci svincolammo e affrettammo il passo fino a raggiungerli. Ci accorgemmo subito che tra loro non era capitato nulla, anzi dalla distanza che Marco teneva da Beatrice intuimmo che doveva esserci stato qualche problema d’intesa. Non sto a raccontare il resto della giornata. Sta di fatto che, dopo quell’incontro, io e Laura incominciammo a frequentarci anche in città e tre anni dopo, finita l’università e trovato un impiego, ci sposammo. Questa storia, per me a lieto fine, ha una sua evidente morale: se vuoi baciare una ragazza, nonostante tu abbia l’alito pesante a causa dell’aglio, è fondamentale, anzi è assolutamente obbligatorio, che pure lei abbia mangiato la bagna cauda… Ovviamente la regola vale anche a parti invertite, come può testimoniare mia cognata Beatrice che da quella volta, a scanso di equivoci, rinunciò, purtroppo per lei, a mangiare la bagna cauda.
Giulia Coronaro