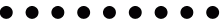Esotico è vocabolo che deriva dal greco exōtikós, con il significato di “proveniente da fuori”. Dal punto di vista etimologico è dunque “esotico” ogni prodotto, stile o idea che appartiene ad altre culture o ad altre terre e la percezione di esotismo è tanto maggiore quanto più quei luoghi sono “lontani” e non solo in senso fisico. Ovviamente la definizione di “esotico” varia a seconda della cultura di chi la adotta; fino a pochi anni fa i cinesi consideravano esotico l’olio d’oliva, i norvegesi l’arancia e i filippini la mortadella. Poi le barriere che storicamente dividevano il mondo in aree in cui persistevano tipicità e tradizioni sono state abbattute in nome di quella che chiamiamo globalizzazione e che altro non è che il progressivo e irreversibile allargamento della sfera delle relazioni sociali finalizzate a superare le barriere materiali e immateriali alla circolazione di persone, cose, informazioni, conoscenze e idee; se ciò rappresenti realmente un aspetto positivo dell’evoluzione umana è ancora presto per dirlo. Un manufatto definito esotico, fino a trent’anni fa, era considerato raffinato ed elitario perché parlava di terre lontane e denunciava una conoscenza più o meno reale di luoghi o abitudini precluse ai più; insomma c’era un tempo in cui un quadro naïf haitiano, una scultura tribale della Costa d’Avorio o una tanka tibetana suscitavano l’orgoglio del proprietario e l’ammirazione dei suoi ospiti. Lo stesso accadeva in tavola quando comparivano prodotti curiosi come la salsa di soia, il chili abanero, il riso patna, il curry o la tequila. La fulminea accelerata alle relazioni e agli scambi a livello mondiale ha tolto gran parte del fascino e dell’esclusività all’inusuale e all’esotico, tanto che mango, papaya, lime, avocado e passion fruit si trovano ora anche nei discount mentre carambola, guava, kumquat e litchi sono assurti a ingredienti irrinunciabili per chef, pasticceri e pasticcioni: per non dire dei super-food esotici come zenzero, quinoa, curcuma e goji, protagonisti di raffazzonate campagne mediatiche e di mediocri performances catodico-gastronomico-salutiste. Il consumo di frutta esotica è stato ostacolato in passato da pregiudizi di vario genere, dettati in gran parte da scarsa informazione e da una buona dose di sospetto verso le “novità”. Che senso ha, pensavano gli italiani – e molti lo pensano ancora oggi – mangiare frutta “estranea” al nostro mondo e alla nostra cultura quando il nostro Paese è così ricco di mele, pere, fragole, meloni, arance, ciliegie e pesche? Cominciamo col dire che la frutta, anzi, qualsiasi frutta, purché matura, fresca e sana, è il migliore alimento disponibile in natura. Moderatamente nutriente, quasi sempre poco calorica, rinfrescante, ricchissima di vitamine e sali minerali, la frutta è la più importante risorsa di “zuccheri buoni” di cui disponiamo e il miglior modo per introdurre nel nostro organismo le fibre indispensabili ad una buona forma fisica. Per quanto riguarda l’estraneità culturale di certi frutti è appena il caso di chiedersi se il ketchup, l’hamburger, la salsa Worchester o la cannella siano proprio figli della nostra cultura. A ben guardare anche il pomodoro, la patata e la melanzana furono a lungo considerati prodotti “esotici” e in un primo tempo giudicati addirittura velenosi. La banana è arrivata in Italia dalla Somalia negli anni ‘30 dopo la disastrosa avventura della “quarta sponda” e oggi ne mangiamo mediamente 10 kg a testa: il terzo frutto più consumato dagli italiani dopo mele e arance. Quando il kiwi (Actinidia chinensis) apparve sul mercato fu guardato con sospetto ma oggi, dopo una trentina d’anni da quando cominciò a essere coltivato in Italia, il nostro paese è in vetta alle classifiche di produzione e il peloso frutto – ricchissimo di vitamina C e non solo – si è addirittura meritato l’indicazione geografica protetta “Kiwi Latina IGP” ed è una presenza consueta e salutare sulle nostre tavole. Tuttavia, se dal 2007 è raddoppiato il consumo degli ananas (grazie soprattutto alla loro fraintesa proprietà di accelerare la digestione) si è però dimezzato il consumo delle pesche e si è sensibilmente ridotto quello dei fichi e delle ciliegie. Come dire che ci siamo dimenticati che l’Italia è il primo produttore di frutta e verdura in Europa. Resta il fatto che molti prodotti esotici sono divenuti, a torto o a ragione, veri e propri feticci della moderna gastronomia e alcuni di essi sono entrati di prepotenza anche nella farmacopea e nelle medicine cosiddette alternative. Una moda? Tutt’altro. Per gli antichi romani erano frutti esotici le nespole del Caspio, le pesche della Persia e le ciliegie del Ponto introdotte in Italia solo nel 73 a.C. dal generale Lucullo di ritorno vittorioso dalla guerra contro Mitriade in Asia Minore. In Grecia avevano la fama di frutti esotici la pera – importata dall’Asia Occidentale all’epoca di Pericle – e il melograno (Punica granatum), simbolo di invincibilità per i persiani, diffuso nel Mediterraneo dai fenici. Senza scendere in ulteriori dettagli è forse il caso di tentare una lettura antropologica del fenomeno “esotismo” che aiuti a comprendere quanto questo risponda a una nostra precisa e antica necessità. Di qualunque genere sia – arte, linguaggio, costume, alimento, strumento o tecnica – ogni manifestazione esotica porta con sè la visione di luoghi lontani e diversi dal nostro paesaggio familiare. Una lontananza che non è da intendersi tanto in senso fisico quanto in quello culturale, e che appartiene al mondo che inizia subito fuori della porta di casa, fuori delle mura della città, fuori da ciò che è per noi l’ambiente “civilizzato”. Nel nostro DNA è scritto che dove inizia la foresta, il deserto, il mare, lì è il mondo che non ci appartiene, che non conosciamo e in cui è facile perdere le coordinate spaziali e culturali che contrassegnano il nostro spazio domestico. Le linee e i confini che separano nettamente quello che sta dentro da quello che sta fuori, stabiliscono una lontananza ideale rispetto all’ignoto e alla paura che generano. Tutti i confini sono però anche labili e la tentazione di oltrepassarli per scoprire mondi diversi è forte. Da sempre chi osa varcare i confini è l’eroe, è l’Ulisse, il Giasone che intraprende viaggi lunghi e pieni di pericoli in luoghi inaccessibili e lontanissimi, che supera prove difficili ed a volte estreme combattendo contro i mostri che popolano il mondo alieno. Oggi la civiltà umana è progredita e la città degli uomini ha dilatato i suoi confini, s’è estesa e ha divorato la foresta, ha riempito il deserto. Il mondo non ha più segreti per gli uomini e i miti sono diventati favole che raccontiamo ai bambini per farli sognare e a noi stessi per consolarci. In un mondo che non ha più misteri, il desiderio di viaggiare è però vivo, vitale; un desiderio di fuga dalla vita sbiadita di tutti i giorni che si manifesta nella ricerca di paesi esotici e dei frutti meravigliosi che essi possono donarci. Ecco il nostro bisogno di arte aborigena, di tatuaggi tribali, di religioni orientali, di diete e prodotti alimentari esotici, di tante mode spesso  effimere, che contengono la premessa e la promessa di doni ed effetti straordinari. L’esotismo, soprattutto quello alimentare, è quanto rimane oggi dei paesaggi fantastici e degli orizzonti spirituali di una volta, con tutto il carico di giovinezza ed immortalità che generavano. Letto così il bisogno di esotico cela una profonda insoddisfazione del presente, una ostinata ricerca del diverso, un’urgenza di sentirsi in qualche modo eroi. Il rischio è che questa ricerca, priva della consapevolezza di ciò di cui abbiamo veramente bisogno, ci renda schiavi di illusioni, di false certezze senza basi scientifiche: esotiche chimere capaci di far più male dei mostri che popolavano i mondi del passato.
effimere, che contengono la premessa e la promessa di doni ed effetti straordinari. L’esotismo, soprattutto quello alimentare, è quanto rimane oggi dei paesaggi fantastici e degli orizzonti spirituali di una volta, con tutto il carico di giovinezza ed immortalità che generavano. Letto così il bisogno di esotico cela una profonda insoddisfazione del presente, una ostinata ricerca del diverso, un’urgenza di sentirsi in qualche modo eroi. Il rischio è che questa ricerca, priva della consapevolezza di ciò di cui abbiamo veramente bisogno, ci renda schiavi di illusioni, di false certezze senza basi scientifiche: esotiche chimere capaci di far più male dei mostri che popolavano i mondi del passato.
Tutto l’esotico che ci manca
Tempo di lettura: 4 minuti
* 1vote