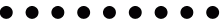Quando il cibo di strada diventa politico
 Su Netflix è da poco disponibile l’ultima fatica di David Gelb, già autore della fortunata docuserie Chef’s Table. Street food, si chiama il nuovo programma. Questa volta il regista lascia le immacolate cucine pluristellate di tutto il mondo per immergersi in un viaggio assai più caciarone attraverso la migliore tradizione del cibo di strada asiatico: dalla prima chef stellata di street food (Jay Fai in Thailandia), fino all’esilarante chef Toyo di Osaka che prepara deliziosi piatti con gli scarti del tonno usato per il sashimi e, infine, alle storie, ricette e tradizioni di famiglia che si intrecciano con le vicissitudini culturali e politiche di India, Indonesia, Corea, Taiwan, Vietnam, Filippine, Singapore. Street Food racconta le varie sfaccettature di un fenomeno ormai di risonanza globale ed eppure così visceralmente dipendente dalle tradizioni locali. Il fascino del rumoroso generatore di un unto baracchino l’abbiamo subito tutti fin da piccoli, che da esso provenisse l’odore della porchetta, quello di fritture miste servite nell’iconico cono di carta gialla, di panelle o “cinque e cinque” (a seconda delle regioni), o dei panzerotti pugliesi. Il cibo di strada è subito festa, clarinetto della banda del paese, ore piccole sui gradini ancora caldi di sole, infanzia rubata agli anni a venire e, soprattutto, quel senso di indulgenza proprio di un’ospitalità condivisa. Eppure, vari sono i problemi (igienici, sociopolitici e sanitari) relativi allo street food, soprattutto nelle aree più povere del mondo. Sebbene ne abbia riconosciuto l’importanza culturale e sociale, soprattutto in quei contesti geografici in cui lo street food funge a tal punto da collante sociale che da esso dipende la capacità di alimentarsi e socializzare delle fasce sociali meno abbienti, a partire dal 1997 la FAO ha cominciato a studiare il fenomeno del cibo di strada, proponendo reports e linee guida per i singoli paesi. La sfida è che l’importanza storica e culturale dello street food venga mantenuta avendo cura, però, che ciò avvenga in migliori condizioni di sicurezza alimentare e senza che sia compromessa la capacità di fasce di popolazione con basso reddito di alimentarsi in modo equilibrato ed economicamente sostenibile (cioè: senza che siano alzati i prezzi). Da qui l’invito della FAO ai governi, spesso ostili alla presenza su suolo pubblico di attività commerciali per uso privato, a promuovere politiche alimentari più sensibili in tema di street food. La politica locale, infatti, spesso non coglie a sufficienza l’importanza del cibo di strada come forma di cultura – come lamenta la scrittrice Chawadee Nualkhair nel primo episodio di Street Food su Netflix, dedicato alla Thailandia: “il cibo di strada è l’aspetto più democratico della cultura tailandese”, dice Nualkhair, soprattutto in un momento di grande isolamento individuale e di polarizzazione della ricchezza. Il cibo di strada, dunque, obbliga chi lo produce e chi lo consuma a mettere in atto continue strategie di negoziazione fra spazio pubblico e spazio privato. In un affascinante libro pubblicato qualche anno fa da MIT Press, “From Loncheras to Lobsta Love: Food trucks, cultural identity and social justice”, gli editori Julian Agyeman, Caitlin Matthews e Hannah Sobel propongono di pensare al cibo di strada come a un mezzo per promuovere la giustizia sociale, in un continuo scambio simbolico fra l’identità collettiva delle comunità che lo producono e le scelte alimentari dei singoli individui. Attraverso un’analisi del movimento dei food trucks in varie città americane come esempio di economia collettiva integrata, secondo gli autori, il cibo di strada può fungere da catalizzatore di una maggiore giustizia sociale. Insomma, un’oculata gestione dello spazio pubblico per la vendita privata di cibo di strada potrebbe aumentare il livello di aggregazione sociale delle comunità, fornendo inoltre un efficace strumento di condivisione contro la marginalizzazione sociale delle minoranze. Viceversa, proposte “colonialiste” di gourmetizzazione del cibo di strada potrebbero snaturarne la spontanea vocazione: quella alla condivisione senza pretese. In Italia forse il dibattito è diverso che in America e nel resto del mondo, ma il settore è in crescita, con molte virate sul gourmet, una giusta insistenza sulla sostenibilità e, fortunatamente, uno zoccolo duro di tradizione popolare che resiste a suon di cartocci e panuozzi. Recentemente ho mangiato in quello che i più ritengono un tempio dello street food europeo, Hija de Sanchez a Copenhagen: per l’equivalente di 25 euro, tre piccoli tacos e una birra. Aldilà del prezzo non propriamente popolare – ma perfettamente proporzionato all’alto costo della vita di Copenhagen e giustificato dal fatto che dietro alla “figlia di Sanchez” si nasconde, in realtà, l’ex pastry-chef del Noma – mi è mancata la generosità della porchetta.
Su Netflix è da poco disponibile l’ultima fatica di David Gelb, già autore della fortunata docuserie Chef’s Table. Street food, si chiama il nuovo programma. Questa volta il regista lascia le immacolate cucine pluristellate di tutto il mondo per immergersi in un viaggio assai più caciarone attraverso la migliore tradizione del cibo di strada asiatico: dalla prima chef stellata di street food (Jay Fai in Thailandia), fino all’esilarante chef Toyo di Osaka che prepara deliziosi piatti con gli scarti del tonno usato per il sashimi e, infine, alle storie, ricette e tradizioni di famiglia che si intrecciano con le vicissitudini culturali e politiche di India, Indonesia, Corea, Taiwan, Vietnam, Filippine, Singapore. Street Food racconta le varie sfaccettature di un fenomeno ormai di risonanza globale ed eppure così visceralmente dipendente dalle tradizioni locali. Il fascino del rumoroso generatore di un unto baracchino l’abbiamo subito tutti fin da piccoli, che da esso provenisse l’odore della porchetta, quello di fritture miste servite nell’iconico cono di carta gialla, di panelle o “cinque e cinque” (a seconda delle regioni), o dei panzerotti pugliesi. Il cibo di strada è subito festa, clarinetto della banda del paese, ore piccole sui gradini ancora caldi di sole, infanzia rubata agli anni a venire e, soprattutto, quel senso di indulgenza proprio di un’ospitalità condivisa. Eppure, vari sono i problemi (igienici, sociopolitici e sanitari) relativi allo street food, soprattutto nelle aree più povere del mondo. Sebbene ne abbia riconosciuto l’importanza culturale e sociale, soprattutto in quei contesti geografici in cui lo street food funge a tal punto da collante sociale che da esso dipende la capacità di alimentarsi e socializzare delle fasce sociali meno abbienti, a partire dal 1997 la FAO ha cominciato a studiare il fenomeno del cibo di strada, proponendo reports e linee guida per i singoli paesi. La sfida è che l’importanza storica e culturale dello street food venga mantenuta avendo cura, però, che ciò avvenga in migliori condizioni di sicurezza alimentare e senza che sia compromessa la capacità di fasce di popolazione con basso reddito di alimentarsi in modo equilibrato ed economicamente sostenibile (cioè: senza che siano alzati i prezzi). Da qui l’invito della FAO ai governi, spesso ostili alla presenza su suolo pubblico di attività commerciali per uso privato, a promuovere politiche alimentari più sensibili in tema di street food. La politica locale, infatti, spesso non coglie a sufficienza l’importanza del cibo di strada come forma di cultura – come lamenta la scrittrice Chawadee Nualkhair nel primo episodio di Street Food su Netflix, dedicato alla Thailandia: “il cibo di strada è l’aspetto più democratico della cultura tailandese”, dice Nualkhair, soprattutto in un momento di grande isolamento individuale e di polarizzazione della ricchezza. Il cibo di strada, dunque, obbliga chi lo produce e chi lo consuma a mettere in atto continue strategie di negoziazione fra spazio pubblico e spazio privato. In un affascinante libro pubblicato qualche anno fa da MIT Press, “From Loncheras to Lobsta Love: Food trucks, cultural identity and social justice”, gli editori Julian Agyeman, Caitlin Matthews e Hannah Sobel propongono di pensare al cibo di strada come a un mezzo per promuovere la giustizia sociale, in un continuo scambio simbolico fra l’identità collettiva delle comunità che lo producono e le scelte alimentari dei singoli individui. Attraverso un’analisi del movimento dei food trucks in varie città americane come esempio di economia collettiva integrata, secondo gli autori, il cibo di strada può fungere da catalizzatore di una maggiore giustizia sociale. Insomma, un’oculata gestione dello spazio pubblico per la vendita privata di cibo di strada potrebbe aumentare il livello di aggregazione sociale delle comunità, fornendo inoltre un efficace strumento di condivisione contro la marginalizzazione sociale delle minoranze. Viceversa, proposte “colonialiste” di gourmetizzazione del cibo di strada potrebbero snaturarne la spontanea vocazione: quella alla condivisione senza pretese. In Italia forse il dibattito è diverso che in America e nel resto del mondo, ma il settore è in crescita, con molte virate sul gourmet, una giusta insistenza sulla sostenibilità e, fortunatamente, uno zoccolo duro di tradizione popolare che resiste a suon di cartocci e panuozzi. Recentemente ho mangiato in quello che i più ritengono un tempio dello street food europeo, Hija de Sanchez a Copenhagen: per l’equivalente di 25 euro, tre piccoli tacos e una birra. Aldilà del prezzo non propriamente popolare – ma perfettamente proporzionato all’alto costo della vita di Copenhagen e giustificato dal fatto che dietro alla “figlia di Sanchez” si nasconde, in realtà, l’ex pastry-chef del Noma – mi è mancata la generosità della porchetta.
di Francesca Iurlaro