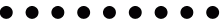Il mio punto di vista sulla genesi dei crostacei sarà anche poco scientifico, ma non mi riesce di trovare altre spiegazioni sulla funzione di quei grovigli di zampe, articolazioni, antenne, protuberanze e spuntoni. Probabilmente finita la creazione, Madre Natura fu colpita dalla “sindrome di Ikea”, quella che ti getta nello sconforto mentre guardi l’armadietto del bagno appena costruito e ti accorgi di aver avanzato un sacco di viti, bulloni, aste e tiranti. Noi comuni mortali li mettiamo in una scatola illudendoci che prima o poi ci torneranno utili. Lei invece affibbiò tutti quei pezzi inutili alla prima creatura che le passava davanti: l’aragosta. E il rosso (da cotto) decapode continua a chiedersi da milioni di anni: “Che senso ha questa accozzaglia di tiranti, arti e giunture? Eppoi perché le chele, l’unico attrezzo che mi tornerebbe utile, è andato all’astice e al granchio anziché a me?”. È vero, all’aragosta mancano quelle efficaci tenaglie capaci di spezzare un dito a chi maneggia maldestramente un astice ma in compenso è dotata di unghioni taglienti e di due lunghissime antenne che funzionano sia come organo di senso che come arma di difesa. In effetti corazzata e minacciosamente attrezzata com’è l’aragosta – oltre al polpo suo nemico giurato – ha ben pochi nemici da cui difendersi. È un animale dai modi pacifici, gran lavoratore ed estremamente sociale che vive in gruppi serrati preferendo mari non troppo freddi. Generalmente più la temperatura dell’acqua è elevata, meno le sue carni sono ambite dai buongustai. Il sapore e la qualità delle oltre 200 tipologie di aragoste conosciute variano molto, in funzione della zona di pesca, della stagione e dell’alimentazione disponibile. Nel golfo del Messico e nel mar delle Antille si pescano quantità incredibili di aragoste dal guscio bruno-rossastro, con grosse macchie bianco-gialle sulla coda. È l’aragosta cubana (Palinurus guttatus), che giunge in Italia congelata, nella maggior parte dei casi precotta, scialba, snervata e stoppacciosa. Va un po’ meglio con l’aragosta rosa maculata del Portogallo, spesso confusa con quella delle Canarie di medio pregio gastronomico, superiore comunque a quello delle aragoste brune del Sud Africa e dall’oceano Indiano. La varietà californiana (Palinurus interruptus) è la più grande del mondo e raggiunge anche i 90 cm di lunghezza ma i suoi pregi finiscono qua. L’aragosta del Madagascar e quella verde della Mauritania spuntano sul mercato i prezzi più bassi grazie alle loro carni spesso gommose e di sapore a dir poco anonimo. Nulla a che vedere con la varietà nostrana (Palinurus elephas o regis), che si cattura sulle coste occidentali del Mediterraneo, soprattutto nei fondali rocciosi e medio-bassi di Sardegna e Sicilia. La sua carne è sublime: candida e tenace, profuma di mare in tempesta, ha un sapore ricco e delicato che lascia la bocca dolce e compiaciuta, senza sgradevoli note ammoniacali. Di solito preferisco gli esemplari femmina – che si riconoscono dalla coda a ventaglio più larga – più ricchi di carne dei maschi. L’apice gustativo si verifica in estate, quando le “aragostesse” custodiscono la riserva di uova ancora da deporre. È una sostanza rosa, elastica, poco compatta, di sapore dolce e delicato che si accumula tra l’addome e la testa e gastronomicamente nota come “corallo”, con cui si fanno salse e salsette per condire pesci o altri crostacei, o per essere gustate tali e quali. Una volta deposte le uova diventano visibili all’esterno, tra le zampe, ma la femmina è spossata, magra e le sue carni perdono ogni attrattiva. Soleva dirmi il grande gastronomo veneto Bepo Maffioli: “l’ultima visione che deve avere l’aragosta è quella del volto del cuoco, a una spanna dalla pentola e a due dalla graticola”.

E non per sadismo o crudeltà ma perché l’aragosta morta sviluppa quasi subito composti azotati che se non proprio velenosi riescono a rendere la sua carne disgustosa come quella del pesce tenuto per giorni sul banco del pescivendolo. Quindi in cucina il prezioso decapode deve arrivare vivo, meglio se non stressato, battagliero e perfettamente integro poiché ogni menomazione – una zampa in meno, la coda spezzata o il carapace incrinato —rappresenterebbe la via d’uscita per notevoli quantità di carni. La cucina di noi carnivori impenitenti, è spesso considerata come un luogo di efferate crudeltà, che indignano gli ambientalisti, gli animalisti e i benpensanti privi di appetito. Tuttavia, gettare l’aragosta viva nell’acqua bollente è un’azione assolutamente malvagia e di pessimo gusto. Per quanto sia ormai certo che i fischi che provengono dalla pentola in ebollizione non siano “urla” (la pregiata vittima non possiede apparato vocale) ma sibili causati dal vapore che esce violentemente dalle “condutture” dell’animale, l’idea di una morte poco compassionevole o addirittura crudele e sadica come questa mi ripugna. Le aragoste non hanno un singolo sistema nervoso, centralizzato, ma un sistema nervoso simmetrico bilaterale che consiste di gangli (gruppo di nervi) per ciascun segmento del corpo. Quindi l’animale non muore subito nemmeno conficcando la punta di un coltello nella parte superiore della testa come suggerito dagli esperti. Il metodo più corretto ed efficace pare essere quello di sottoporre l’aragosta ad “elettrocuzione”, cioè di sopprimerla in maniera definitiva mandando in cortocircuito l’intero sistema nervoso in un paio di secondi ed evitandole penose agonie. Basta una scarica elettrica di bassa intensità (1,5 Ampère) come quella inferta all’animale dal nuovissimo Crustastun, presentato recentemente a Londra come il miglior modo per uccidere i crostacei (aragoste, astici, granchi, granzeole ecc.) senza provocar loro inutili sofferenze. Appena avrò 3000 Euro da investire me lo comprerò per metterlo doverosamente “a una spanna dalla pentola e a due dalla graticola”. Oggi l’aragosta andrò a mangiarmela dal Biagio al Sant’Egidio di Marta. E senza nemmeno chiedergli se e come l’abbia assassinata prima di stenderla pietosamente sulla graticola.
Sergio G. Grasso