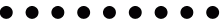Prendere pesci era soprattutto un gioco, un passatempo. Servivano principalmente le mani per rovistare tra i sassi e sorprendere le veloci alborelle (alburnus alborella), il pesce nono (alphanius fasciatus), le tranquille marcandole (cyclopterus lumpus), le scardole (scardinus erytrophthalmus) e soprattutto gli imprendibili gamberi di fiume, all’inizio soltanto autoctoni e poi inseriti da acque lontane (potamon fluvialis). Non c’erano ancora le canne retrattili in resina con riduzione periscopica all’infinito. I mulinelli leggeri, gli ami di tutte le forme e i colori delle esche artificiali. Destinati poi soprattutto alla pesca amatoriale dei laghetti. Per noi ragazzini del secondo dopoguerra senza molti diversivi, bastavano una bacchetta qualsiasi, un pezzo di filo, più tardi addirittura di nylon, un amo piccolissimo. E per unica esca il povero lombrico, comune sotto le zolle, vecchi tronchi, pietre. E, qualche volta, chicchi di mais o briciole di pane vecchio. Ma non c’è voluto molto per arrivare alle fornitissime pescherie di ogni mercato, alle molte varietà di specie indispensabili a una gastronomia dalle molte pretese che andasse oltre lo stoccafisso battuto o le immancabili sardine da fare in saor. La cucina, le diete, la cultura della tavola, il mangiare diverso, hanno preteso gli allevamenti cioè l’acquacoltura con le tonnellate di carpe e di salmone, ma anche di orate, di branzini, di anguille, di trote fario. Secondo il cuoco Francesco Chapusot operativo a metà dell’Ottocento presso l’ambasciata inglese accreditata dai Savoia, la trota è una dei migliori pesci d’acqua dolce che lui proponeva in una quindicina di ricette. Giovanni Vialardi, cuoco pasticciere nella Torino di qualche decennio dopo, dedicava undici ricette alle trote distinguendole per origini: di fiume anche di foce, di lago, di torrente di montagna, ognuno con le proprie rintracciabili differenze. Si è quindi diffusa, con la crescita di una certa ristorazione, la conoscenza di specie semisconosciute, provenienti a tonnellate soprattutto da altri mari, che hanno alterato le nostre tradizioni culinarie che avevano nel solo Mediterraneo scelte di pesci uguali ma diversi per l’influenza della loro alimentazione, della salinità dell’acqua, del clima. Così che una sardina del mare delle Marche è diversa da quella pescata nell’Alto Adriatico. Ma si tratta sempre di pesce di mare, quello d’acqua dolce c’è ancora, patrimonio di una cucina che non è soltanto rivierasca perché può sempre contare su fiumi e laghi, torrenti di montagna, stagni, bacini irrigui e foci. E allora ecco anguille e carpe, il persico e il luccio, salmerini e tinche e l’immancabile trota. In forno, in padella in umido, in brodo, crudo, alla griglia, alla piastra, fritto…Con antichi mestieri, con fantasia, con l’immancabile ricorso alle memorie familiari. Un piatto “povero” quello con il pesce d’acqua dolce, meno rintracciabile di un tempo ma ancora delizia gastronomica a conferma di delicati sapori e di credibili diete.
Quando si pescava con le mani
Tempo di lettura: 1 minuto
0votes