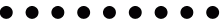Fino a una decina di anni fa la cucina giapponese era considerata come l’ennesima stranezza di pochi consumatori un po’ snob. Oggi si è convertita in un successo planetario che fa riflettere i sociologi. Sushi e sashimi segnano la caduta di un presupposto fondamentale della cucina italiana: la dignità del cibo si misura con la sua ampiezza sensoriale. Se un italiano cresciuto a lasagne, gorgonzola, mortadella e grigliate riesce a dirsi soddisfatto dal sapore esile e sommesso del pesce crudo, ogni barriera gastronomica è potenzialmente abbattuta. Nulla è più distante dai nostri canoni gastronomici delle preparazioni giapponesi. A rigor di logica non dovrebbero nemmeno essere considerate “cucina”, visto che questo termine deriva dal latino coquere (cuocere). Ciò che manca alla cucina nipponica è il senso di “amalgama” della ricetta, la fusione degli elementi, l’attesa di un risultato che travalica la somma dei singoli ingredienti. Mi spiego. Sushi e norimaki hanno una costruzione prevedibile e immutabile, basata su dicotomie e contrapposizioni più culturali (Yin/Yang) ed estetiche che organolettiche. La cucina giapponese sembra più concentrata sulla realizzazione del cuoco che sulla gratificazione del cliente (è forse il caso di ricordare che l’educazione nipponica scoraggia ogni manifestazione evidente di emotività e censura ogni espressione di piacere fisico), sulla forma più che sulla sostanza, sulle regole più che sulla creatività. I nipponici sono portati al distacco emotivo e alla freddezza mentre per la nostra cultura alimentare il “raffreddarsi” di un piatto è quasi una calamità. Eppure in un ristorante giapponese dimostriamo di gradire la gommosità di un riso freddo e scondito, il viscidume dell’anguilla cruda, il mucido dell’alga kombu e l’insipido del tofu. Allo stesso modo ci adattiamo alla purezza minimalista dei cibi, all’assenza di gerarchie sociali, di sequenze temporali tra i piatti. Insomma, dimentichiamo il nostro spirito conviviale e festaiolo adeguandoci all’atmosfera raccolta e silenziosa, quasi da meditazione eppure senz’anima. Poco, crudo, freddo, insipido e viscido sono esattamente agli antipodi del nostro DNA alimentare. Eppure hanno successo e sarebbe un errore grossolano considerare tutto ciò come una moda o un esotismo estemporaneo. Personalmente lo interpreto come il segno netto e lacerante di una forte mutazione gastrosofica che vede la cucina “tonale” (quella che mescola e fonde i vari ingredienti come in una sinfonia) perdere credito di fronte a quella “timbrica”, in cui la separazione dei solisti e la scomposizione delle partiture semplifica il ruolo del degustatore e lo solleva dall’angoscia del riconoscimento e della riflessione. Nello stesso tempo la figura del commensale diviene sempre più passiva, subordinata alla dittatura del cuoco che si esprime ad Oriente con un ortopedico rispetto di antiche regole, e qui da noi con una “creatività” poco autorale e molto esibizionistica. Le radici storiche del sushi/sashimi spiegano bene la distanza culturale tra il nostro vissuto alimentare e quello del Sol Levante. A partire dalla millenaria proibizione al consumo di carne. Il più antico documento in materia risale al 675 d.C. data in cui l’imperatore Temmu proibì l’uccisione e il consumo di molti animali. Altre leggi emanate durante l’ottavo e il nono secolo esclusero gradatamente tutti i mammiferi, le scimmie, i serpenti e perfino il pollame, sanzionando il consumo di questi animali anche con la pena capitale. Il divieto era già considerato un tabù culturale al tempo dell’Impero di Shomu (724–749) quando i giapponesi introdussero nel loro Shintoismo originario molti riferimenti al Buddhismo, incluso quello alla sacralità degli esseri viventi. Nel XV secolo fu tolto il divieto alimentare sul pollame ma rimasero le prescrizioni sui quadrupedi e i mammiferi, sia per i presupposti religiosi sia per non decimare gli animali da lavoro in risaia (vacche e cavalli) in periodi di carestia. Dieci secoli di disabitudine alla carne hanno profondamente condizionato la cucina giapponese che proprio per questo fa poco uso di spezie e non conosce le lunghe cotture. Non basta. Il mancato allevamento di mammiferi da carne ha tolto ai nipponici il piacere del latte, fino a creare nella popolazione un diffuso deficit enzimatico di lattasi. La privazione di carne e latticini ha anche prodotto un’avversione per i gusti grassi e oleosi, cosicché gli oli (vegetali) sono sempre stati usati solo per cucinare e mai per condire. Il divieto di consumare carni “di terra” cessò solo nel 1868, quando il giovane imperatore Meiji si mostrò ad un banchetto mangiando carne di vitello Wagyu (quello che noi oggi chiamiamo Kobe) allevato proprio per questo scopo. Fino ad allora nel paese del Sol Levante le uniche fonti proteiche erano stati i legumi (soya) e soprattutto la fauna marina, esclusa dai tabù buddisti. I giapponesi hanno dunque sviluppato – giocoforza – uno speciale amore per il pesce e si sono sempre preoccupati di trattarlo con grande attenzione per le sue qualità e assoluto riguardo per la sua integrità. Un antico proverbio dice: “Pesca il pesce e mangialo subito senza fuoco, griglialo il giorno dopo e lessalo dopo due”. Il consumo di pesce crudo tagliato a julienne (namasu) tuffato in aceto di riso è testimoniato fin dal periodo Nara (710-794). Il sashimi – sottili fettine di pesce crudo intinte in salsa di soya e insaporito con radice di wasabi grattugiata – compare solo nel 1600, quando si iniziò a produrre industrialmente la salsa di soya, prima molto costosa. Il Nigiri-sushi (sushi significa “ripieno” e nigiri vale per “modellato a mano”) compare solo nell’800 nella città di Edo, grazie a Yohei Hanaya, che iniziò a vendere bocconcini di riso aromatizzato all’aceto con sopra una fettina di pesce crudo. Si trattava di una semplificazione del metodo con cui si conservava il pesce già nell’ VIII° secolo d.C.: il nare zushi, preparato con carpe lessate e ricoperte di riso cotto, pressate e lasciate fermentare almeno un anno. Hanaya non fece che mescolare il riso del Nigiri-sushi al crudo del sashimi, sostituendo l’acidità lattica della fermentazione con l’aromatizzazione all’aceto di riso. Il successo ispirò numerose varianti, come il norimaki, destinato ai vegetariani, in cui un’alga nori avvolgeva uno strato di riso aromatizzato all’aceto dentro al quale erano racchiusi vegetali lessati. Lo confesso, ciò che mi attrae della ristorazione giapponese è più la tecnica che la sostanza, più l’abilità del cuoco a mantenere integra la materia prima che il risultato “gourmet” del piatto. A dirla tutta frequento molti ristoranti giapponesi di buon livello ma solo per motivi professionali e senza particolare trasporto. I sushi-bar non mi attraggono e quando ho bisogno di pesce crudo eccellente (capita spesso) vado a farmi un weekend tra Gallipoli e Bari, le due capitali italiane del crudo-vivo. Se è proprio urgente mi imbarco su un peschereccio a Civitavecchia come “mezzo mozzo”, tiro su le rete coi marinai, cucino in cambusa per l’equipaggio e mi faccio pagare in gamberoni e mazzancolle strappati quasi a morsi dalle rete da pesca. Crudo e crudele, ma con l’anima.
Sergio G. Grasso