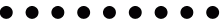In quanto animale sociale l’essere umano trae il massimo appagamento dalla condivisione dei propri bisogni e sentimenti con i suoi simili: dalle gioie ai dispiaceri, dalla casa alla chiesa, dal sesso (più o meno tradizionale) al cibo. Noi condividiamo il cibo abitualmente in forma privata: a casa, in famiglia o con gli amici, al chiuso o all’aperto, al ristorante o in occasione di un picnic sui prati. Sempre più spesso ci concediamo anche il lusso – antico e per nulla indecoroso – di mangiare pubblicamente, con le mani, bighellonando, appoggiati a un muretto, seduti su una panchina o in macchina. Il “cibo-di-strada” – veloce, poco costoso, preparato al momento e servito da bancarelle, chioschi, furgoni o mezzi ambulanti – ha ritrovato la sua arcaica dignità sacrificandosi nell’inutile anglicismo modaiolo di “street-food” fino a diventare un’icona gastronomica, un fenomeno di massa che piace sia ai carnivori che ai vegani, che richiama teenagers e meno giovani, benestanti e squattrinati. Mangiare “stigghiòla” e “arancini” a Ballarò, “scartossi de pesse” e “bovoli” a Rialto, “supplì” e filetto di baccalà a Campo de’ Fiori, “lampredotto” in Piazza della Signoria, “cuoppo fritto” e “père e musso” a Mergellina o “folpo bollito” in Prato della Valle è la risposta un po’ stizzita a un universo alimentare diventato anche in Italia traboccante e artificioso, è la disapprovazione verso il formalismo della tavola e l’ipocrisia dei menù stellati, il tentativo di sottrarsi all’egemonia della cucina-spettacolo e delle microporzioni. Sono convinto che ogni genius-loci (l’entità sovrannaturale che nell’Antica Roma era considerata la protettrice di ogni luogo) si sazi solo di buon cibo-di-strada. I mille genii del Belpaese si ungono le dita di polpette e pesciolini fritti, di panelle e arrosticini, di piadine e ciarimboli; quelli francesi di crêpes, gli indiani di samosa, i tunisini di falafel, gli argentini di empanadas, i messicani di burritos, i russi di bliny, i turchi di burek, i cinesi di tang yuan, gli alsaziani di pretzel… E sotto lo sguardo bene volo del proprio genius-loci, due miliardi e mezzo di persone nel mondo secondo la FAO, consumano o comprano il pasto quotidiano sulla strada. Non per moda ma per tradizione o ineluttabilità. Non basta cuocere un cibo all’aperto per renderlo “di-strada”: bisogna offrirlo, venderlo o barattarlo in strutture semplici, preferibilmente mobili. Agli albori della vicenda umana, l’idea di un locale destinato alla preparazione e alla cottura dei cibi (ma anche l’idea stessa di “strada”) era ben lungi dall’affacciarsi alla mente di Homo sapiens. I fuochi accesi all’interno di grotte e spelonche rendevano l’aria irrespirabile e i cibi venivano sempre cucinati all’aperto per il proprio nucleo famigliare e non per ipotetici e inesistenti “clienti”. Dodici mila anni fa, superato il nomadismo in favore di una vita stanziale, Homo continuò a cuocere i propri pasti all’esterno delle capanne, un po’ per non soffocare (i primi camini sul tetto delle case sono documentati solo nell’Egitto predinastico), un po’ per evitare di dar fuoco alle case fatte di legno e paglia; anche in questo caso il cibo era destinato solo al consumo del proprio gruppo. Bisogna arrivare al III secolo a.C. per trovare la prima traccia letteraria di un vero “street-food”, quello preparato dai venditori ambulanti di pesce fritto nel porto di Alessandria d’Egitto. Pratico, veloce e conveniente, questa usanza divenne comune ad Atene, nel cui agora si potevano comprare koulouri (ciambelle d’orzo ricoperte di sesamo), plakountes (sfogliatelle farcite al miele), tyropites (sorta di piadine al formaggio), kicoropites (focacce alla cicoria), zuppe di fave o lenticchie, olive condite e strayalia (ceci abbrustoliti). Lo street-food greco fu accolto con entusiasmo dai Romani, notoriamente poco inclini a cucinare in casa, vuoi per pigrizia, vuoi per il terrore degli incendi che funestavano regolarmente l’Urbe. Le rare cucine (culinae) delle domus più importanti (come la casa dei Vettii a Pompei) erano utilizzate solo per i pasti della servitù: sono arrivate fino a noi estremamente piccole e disadorne, limitate a un bancone in muratura per le braci, un piccolo forno per il pane e un lavello. I ricchi e i benestanti preferivano mandare i servi ad acquistare le vivande già cotte nei “termopolia” (letteralmente “spacci di cose calde”, quasi sempre affacciati sulle vie principali) o presso i molti venditori ambulanti che giravano per le vie della città. Chi gremiva la strada, commercianti, operai e viaggiatori, frequentava le tabernae (trattorie), le popinae (osterie) o le gurgustia (bettole), tutti locali di dubbia reputazione nei quali oltre a mangiare e bere si praticavano i giochi d’azzardo e la prostituzione. Questi che noi oggi definiremmo “take-away” o “fast-food” erano una presenza costante a Roma, nel Foro, nella Suburra, attorno ai teatri e gli stadi. Cauponae, thermopolia e tabernae sorgevano nei luoghi più affollati di ogni città dell’impero, da Efeso a Bordeaux, da Cartagine a Siracusa, da Antiochia a Ostia, da Salisbury a Ercolano; nella sola Pompei se ne contano almeno 118 di cui 20 collocate sulla frequentatissima Via dell’Abbondanza. In tutto il medioevo nelle grandi città si consumava cibo pronto e a buon mercato. Nel ‘200 a Parigi imperversavano per le strade i “pâstés”, piccoli timballi di pasta ripieni di carne e verdure che potevano essere mangiati con una sola mano senza interrompere il lavoro. Quasi identici erano i grandi ravioli di lardo, carne e legumi che i minatori della Cornovaglia, dal 1400 fino al 1970, compravano dagli ambulanti prima di scendere sottoterra, e il cui ultimo cantuccio, il più sudicio di polvere e terriccio veniva buttato a terra per propiziarsi la protezione degli spiriti, notoriamente di bocca buona. Nelle città di mare inglesi già nel XVI secolo carretti trainati da cavalli vendevano quei cartocci di fritture di pesce che nel 1860 ispirarono a Joseph Malin l’idea di aprire a Londra il primo spaccio di “fish and chips”. Oltreoceano, nell’800 apparvero per la prima volta in Texas i “chuck-vagon”, vere e proprie cucine ambulanti che rifocillavano i convogli di coloni diretti a ovest, i corrieri postali e i cowboys che governavano le mandrie alle  migrazioni stagionali. Risolto – ma non per tutti – il problema della fame ed estinta ogni curiosità cibaria, il dilemma dell’onnivoro occidentale oscilla tra la gola e l’appetito. Poco importa se il pranzo è stato sostanzioso e la cena con gli amici si annuncia impegnativa: ai colori, ai profumi e alle seduzioni gustative di un “camion-cucino”, di una “apetta” o di un chiosco di cibo-di-strada non si resiste nemmeno a metà pomeriggio. A Bombay come a Milano, a Tokio come a Sydney o a Reikiavik, ungersi le dita, impataccarsi di salse la camicia o la cravatta o girare per piazze e mercati con il mento variegato di misteriosi intingoli non crea imbarazzo. Perché lo street-food rappresenta in tutto il mondo l’ultimo bastione contro la globalizzazione, una rivendicazione di identità, l’essenza istintiva di un territorio e della sua cultura, da assimilare a piccoli morsi e col vento in faccia.
migrazioni stagionali. Risolto – ma non per tutti – il problema della fame ed estinta ogni curiosità cibaria, il dilemma dell’onnivoro occidentale oscilla tra la gola e l’appetito. Poco importa se il pranzo è stato sostanzioso e la cena con gli amici si annuncia impegnativa: ai colori, ai profumi e alle seduzioni gustative di un “camion-cucino”, di una “apetta” o di un chiosco di cibo-di-strada non si resiste nemmeno a metà pomeriggio. A Bombay come a Milano, a Tokio come a Sydney o a Reikiavik, ungersi le dita, impataccarsi di salse la camicia o la cravatta o girare per piazze e mercati con il mento variegato di misteriosi intingoli non crea imbarazzo. Perché lo street-food rappresenta in tutto il mondo l’ultimo bastione contro la globalizzazione, una rivendicazione di identità, l’essenza istintiva di un territorio e della sua cultura, da assimilare a piccoli morsi e col vento in faccia.
Nomadismi alimentari
Tempo di lettura: 4 minuti
0votes