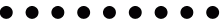Nel V secolo Ippocrate, il padre della medicina, mise a punto una bevanda a base di vino bianco, fiori di dittamo di Creta, capolini di assenzio (Arthemisia absinthium) e foglie di ruta destinata ai pazienti debilitati e inappetenti. Il gusto decisamente amaro del vino “ippocraticum” o “absinthiatum” fu ingentilito dai romani con l’aggiunta di miele, anice e sedano e indicato da Plinio il Vecchio per “vincere l’inedia, il languore di cibo”. I monaci erboristi medioevali che avevano appreso nel X secolo i segreti della distillazione degli alchimisti arabi, riconobbero che lo stimolo della fame era dovuto ad alcune sostanze amare (eupeptiche) che agivano sulla mucosa orale – non sullo stomaco come pensava Ippo-crate – stimolando la secrezione salivare come accade nell’atto della masticazione. Ottennero così dei liquori o elixir (dall’arabo al-iksīr) debolmente alcolici, “cordiali” (che fanno bene al cuore) e “apritivi” (che aprono all’appetito). Tuttavia, bere prima del pasto con scopo rituale è pratica molto più arcaica, raffigurata in alcuni fregi assiri e in molti affreschi egizi in cui personaggi di rango, re e faraoni, sorbiscono con lunghe cannucce un fermentato alcoolico e amarognolo (la birra) mentre i servi allestiscono il banchetto. Il vero e proprio rito conviviale di “aprire” il corpo al pasto è descritto nel IV sec. a.C da Filosseno da Citera, poeta greco di genere parodico-gastronomico; nel suo “Convito” si legge che per stimolare l’appetito degli invitati, un sontuoso banchetto fu fatto precedere da molti deipsos (spuntini) come dolci al latte (glageròs), biscotti al miele e sesamo, formaggio con latte e miele e pasticceria leggera. Anche nella Roma dei Cesari prima della cena vera a propria venivano lasciati a disposizione degli ospiti vassoi di stuzzichini (gustationes) accompagnati da libagioni di vino mielato (mulsum) e che per questo motivo Cicerone chiama “promulsis”. Secoli dopo la caduta di Roma e la sciagura delle invasioni barbariche, Marco Polo e altri viaggiatori percorrendo la Via delle Spezie portarono dall’Oriente non tanto la pasta – che già da almeno duecento anni si produceva a Palermo, Genova e Napoli – ma spezie preziose come la noce moscata, i chiodi di garofano, la cannella, il rabarbaro, la china e lo zenzero. Distillatori, speziali e vinattieri riuscirono in tal modo non solo a regalare un tocco nuovo ed esotico a molti vini e bevande ma anche a dare una presunta dignità a beveraggi fino ad allora a dir poco riprovevoli. Più tardi, con Colombo, giunsero dalle Americhe nuove materie prime da distillare come il mais e la patata ma anche il tocco piccante del peperoncino che, per il suo benefico effetto sulla digestione, veniva aggiunto dagli osti spagnoli al vino rosso che già nel ‘600 accompagnava le tapas di olive, formaggio, prosciutto, polpo e calamari fritti. Il concetto odierno di “aperitivo” è rimasto ancora quello di una bevanda specificamente pensata per stuzzicare l’appetito. Se ne fa risalire l’invenzione (meglio sarebbe dire la riscoperta) al torinese Antonio Benedetto Carpano che creò e commercializzò il primo Vermouth (temine germanico per assenzio) a Torino nel 1786. Ispirato dal vinun hippocraticum, Carpano partì dal Moscato di Canelli, già molto aromatico di suo, e vi lasciò macerare dentro una combinazione di erbe e spezie, fra cui i fiori di Arthemisia absinthium e la corteccia di China calisaya. Anni dopo Vittorio Emanuele II che ne ebbe in dono una cassa da Cavour, rimase entusiasmato da quel punt e mès (in torinese punto e mezzo) di amaro che aveva in più rispetto ad altri. Il Vermouth Carpano, ribattezzato Punt&Mes, fu nominato seduta stante “Aperitivo Ufficiale di Corte” e divenne l’irrinunciabile presenza ai sontuosi pre-cena del Palazzo in cui si servivano paté di coniglio, vitello tonnato, crostini ai tartufi, uova, pomidoro e cipolle ripiene, carne cruda, peperoni grigliati all’acciuga. Oggi, il rituale dell’aperitivo si è evoluto fino ad abbracciare quel paio d’ore prima di cena in cui ci si incontra per chiudere la giornata lavorativa davanti a un bicchiere di vino, una birra, un cocktail leggero e qualcosa da spiluccare, sia questo un “cicchetto” (a Venezia) una “svojatùra (a Roma), delle patatine, qualche oliva o un piattino di mandorle e arachidi salate; cose poco impegnative, salate quanto basta per stimolare la sete e che, bene o male, solleticano l’appetito e predispongono alla cena. Per promuovere l’evento i gestori di bar e pub si sono inventati formule ricche, sostanziose e costose, con nomi spesso improbabili (aperi-cena, aperitivo-cenato, rinforzato, lungo) mettendo in bella mostra sul bancone fritti e tempura, insalate di riso e di pasta, pizzette, uova sode, tartine, tramezzini, supplì, spiedini, frittate, involtini, cornetti salati, club sandwiches, friandises, canapés, amuse gueule, tapas, finger food, vol-au-vents, bagels… quanto basta per alzarsi dal tavolo senza più un briciolo di fame. È il trionfo del “Happy hour”, una locuzione nata all’epoca della Prima Guerra Mondiale per indicare il periodo di intrattenimento alcoolico concesso a fine turno ai militari imbarcati sulle navi della Marina degli Stati Uniti; happy (felice) era evidentemente un eufemismo per “leggermente ubriaco”. Nel 1920, con l’intento di moralizzare la società americana, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Volstead Act che impose il divieto di fabbricazione, vendita, importazione e consumo di alcolici. Ai milioni di americani che fino al 1933 volevano continuare a bere non restava che acquistare sul mercato nero birra, whiskey, rum e ogni altra forma di surrogato clandestino adulterato. L’happy hour si trasferiva dalle navi agli “speakeasy”, locali clandestini che vendevano alcolici, quasi sempre autoprodotti e nei quali si poteva bere impunemente un cocktail prima di andare al ristorante dove l’alcol non poteva essere servito. Al di là del piacere conviviale del consumatore, l’happy hour inteso come offerta di cibi e bevande a prezzi scontati è diventato un valido stratagemma per promuovere l’immagine e gli incassi di molti pub, bar e ristoranti. L’antesignano di questo tipo di marketing fu il Phil Kenny Cafe di Hollywood (California) che sulle locandine pubblicitarie del febbraio 1955 si promuove così: “RITORNA L’HAPPY HOUR DALLE 17 ALLE 18 CON TUTTE LE BEVANDE AL PREZZO DI 25 CENTESIMI!” La spinta contro la guida in stato di ebbrezza ha ridimensionato in una certa misura gli aspetti negativi dell’happy hour. Un po’ dovunque l’abbondanza e la varietà di cibi ha avuto la funzione di abbassare il contenuto di alcol nel sangue dei clienti. In molti paesi sono comunque state introdotte delle limitazioni, è il caso della Repubblica d’Irlanda in cui dal 2003 l’Intoxicating Liquor Act vieta l’happy-hour, così come nella città di Glasgow, nella provincia canadese dell’Alberta, nello stato del Massachusetts e, dal 1984, in tutte le basi militari americane negli States e all’estero.
Nel V secolo Ippocrate, il padre della medicina, mise a punto una bevanda a base di vino bianco, fiori di dittamo di Creta, capolini di assenzio (Arthemisia absinthium) e foglie di ruta destinata ai pazienti debilitati e inappetenti. Il gusto decisamente amaro del vino “ippocraticum” o “absinthiatum” fu ingentilito dai romani con l’aggiunta di miele, anice e sedano e indicato da Plinio il Vecchio per “vincere l’inedia, il languore di cibo”. I monaci erboristi medioevali che avevano appreso nel X secolo i segreti della distillazione degli alchimisti arabi, riconobbero che lo stimolo della fame era dovuto ad alcune sostanze amare (eupeptiche) che agivano sulla mucosa orale – non sullo stomaco come pensava Ippo-crate – stimolando la secrezione salivare come accade nell’atto della masticazione. Ottennero così dei liquori o elixir (dall’arabo al-iksīr) debolmente alcolici, “cordiali” (che fanno bene al cuore) e “apritivi” (che aprono all’appetito). Tuttavia, bere prima del pasto con scopo rituale è pratica molto più arcaica, raffigurata in alcuni fregi assiri e in molti affreschi egizi in cui personaggi di rango, re e faraoni, sorbiscono con lunghe cannucce un fermentato alcoolico e amarognolo (la birra) mentre i servi allestiscono il banchetto. Il vero e proprio rito conviviale di “aprire” il corpo al pasto è descritto nel IV sec. a.C da Filosseno da Citera, poeta greco di genere parodico-gastronomico; nel suo “Convito” si legge che per stimolare l’appetito degli invitati, un sontuoso banchetto fu fatto precedere da molti deipsos (spuntini) come dolci al latte (glageròs), biscotti al miele e sesamo, formaggio con latte e miele e pasticceria leggera. Anche nella Roma dei Cesari prima della cena vera a propria venivano lasciati a disposizione degli ospiti vassoi di stuzzichini (gustationes) accompagnati da libagioni di vino mielato (mulsum) e che per questo motivo Cicerone chiama “promulsis”. Secoli dopo la caduta di Roma e la sciagura delle invasioni barbariche, Marco Polo e altri viaggiatori percorrendo la Via delle Spezie portarono dall’Oriente non tanto la pasta – che già da almeno duecento anni si produceva a Palermo, Genova e Napoli – ma spezie preziose come la noce moscata, i chiodi di garofano, la cannella, il rabarbaro, la china e lo zenzero. Distillatori, speziali e vinattieri riuscirono in tal modo non solo a regalare un tocco nuovo ed esotico a molti vini e bevande ma anche a dare una presunta dignità a beveraggi fino ad allora a dir poco riprovevoli. Più tardi, con Colombo, giunsero dalle Americhe nuove materie prime da distillare come il mais e la patata ma anche il tocco piccante del peperoncino che, per il suo benefico effetto sulla digestione, veniva aggiunto dagli osti spagnoli al vino rosso che già nel ‘600 accompagnava le tapas di olive, formaggio, prosciutto, polpo e calamari fritti. Il concetto odierno di “aperitivo” è rimasto ancora quello di una bevanda specificamente pensata per stuzzicare l’appetito. Se ne fa risalire l’invenzione (meglio sarebbe dire la riscoperta) al torinese Antonio Benedetto Carpano che creò e commercializzò il primo Vermouth (temine germanico per assenzio) a Torino nel 1786. Ispirato dal vinun hippocraticum, Carpano partì dal Moscato di Canelli, già molto aromatico di suo, e vi lasciò macerare dentro una combinazione di erbe e spezie, fra cui i fiori di Arthemisia absinthium e la corteccia di China calisaya. Anni dopo Vittorio Emanuele II che ne ebbe in dono una cassa da Cavour, rimase entusiasmato da quel punt e mès (in torinese punto e mezzo) di amaro che aveva in più rispetto ad altri. Il Vermouth Carpano, ribattezzato Punt&Mes, fu nominato seduta stante “Aperitivo Ufficiale di Corte” e divenne l’irrinunciabile presenza ai sontuosi pre-cena del Palazzo in cui si servivano paté di coniglio, vitello tonnato, crostini ai tartufi, uova, pomidoro e cipolle ripiene, carne cruda, peperoni grigliati all’acciuga. Oggi, il rituale dell’aperitivo si è evoluto fino ad abbracciare quel paio d’ore prima di cena in cui ci si incontra per chiudere la giornata lavorativa davanti a un bicchiere di vino, una birra, un cocktail leggero e qualcosa da spiluccare, sia questo un “cicchetto” (a Venezia) una “svojatùra (a Roma), delle patatine, qualche oliva o un piattino di mandorle e arachidi salate; cose poco impegnative, salate quanto basta per stimolare la sete e che, bene o male, solleticano l’appetito e predispongono alla cena. Per promuovere l’evento i gestori di bar e pub si sono inventati formule ricche, sostanziose e costose, con nomi spesso improbabili (aperi-cena, aperitivo-cenato, rinforzato, lungo) mettendo in bella mostra sul bancone fritti e tempura, insalate di riso e di pasta, pizzette, uova sode, tartine, tramezzini, supplì, spiedini, frittate, involtini, cornetti salati, club sandwiches, friandises, canapés, amuse gueule, tapas, finger food, vol-au-vents, bagels… quanto basta per alzarsi dal tavolo senza più un briciolo di fame. È il trionfo del “Happy hour”, una locuzione nata all’epoca della Prima Guerra Mondiale per indicare il periodo di intrattenimento alcoolico concesso a fine turno ai militari imbarcati sulle navi della Marina degli Stati Uniti; happy (felice) era evidentemente un eufemismo per “leggermente ubriaco”. Nel 1920, con l’intento di moralizzare la società americana, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Volstead Act che impose il divieto di fabbricazione, vendita, importazione e consumo di alcolici. Ai milioni di americani che fino al 1933 volevano continuare a bere non restava che acquistare sul mercato nero birra, whiskey, rum e ogni altra forma di surrogato clandestino adulterato. L’happy hour si trasferiva dalle navi agli “speakeasy”, locali clandestini che vendevano alcolici, quasi sempre autoprodotti e nei quali si poteva bere impunemente un cocktail prima di andare al ristorante dove l’alcol non poteva essere servito. Al di là del piacere conviviale del consumatore, l’happy hour inteso come offerta di cibi e bevande a prezzi scontati è diventato un valido stratagemma per promuovere l’immagine e gli incassi di molti pub, bar e ristoranti. L’antesignano di questo tipo di marketing fu il Phil Kenny Cafe di Hollywood (California) che sulle locandine pubblicitarie del febbraio 1955 si promuove così: “RITORNA L’HAPPY HOUR DALLE 17 ALLE 18 CON TUTTE LE BEVANDE AL PREZZO DI 25 CENTESIMI!” La spinta contro la guida in stato di ebbrezza ha ridimensionato in una certa misura gli aspetti negativi dell’happy hour. Un po’ dovunque l’abbondanza e la varietà di cibi ha avuto la funzione di abbassare il contenuto di alcol nel sangue dei clienti. In molti paesi sono comunque state introdotte delle limitazioni, è il caso della Repubblica d’Irlanda in cui dal 2003 l’Intoxicating Liquor Act vieta l’happy-hour, così come nella città di Glasgow, nella provincia canadese dell’Alberta, nello stato del Massachusetts e, dal 1984, in tutte le basi militari americane negli States e all’estero.
L’aperitivo da Ippocrate all’Happy Hour
Tempo di lettura: 4 minuti
0votes