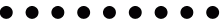Sulla targhetta c’era scritto: Studio Medico Legale. Controllai l’indirizzo che mi ero appuntato: collimava tutto: via, numero, piano, ma non diceva che si trattava di uno studio medico legale. Bussai leggermente; qualche passo dentro e mi aprì una donna secca, alta, austera. Era il ritratto della signorina Rottenmeier, quella di Heidi.
Sulla targhetta c’era scritto: Studio Medico Legale. Controllai l’indirizzo che mi ero appuntato: collimava tutto: via, numero, piano, ma non diceva che si trattava di uno studio medico legale. Bussai leggermente; qualche passo dentro e mi aprì una donna secca, alta, austera. Era il ritratto della signorina Rottenmeier, quella di Heidi.
“Sono stato …” Stese un braccio per indicarmi che dovevo entrare in un’altra stanza. La porta era socchiusa. “Permesso?” Dentro, seduto dietro una pesante scrivania c’era un bell’uomo, dai capelli impomatati, che batteva il tagliacarte su un fascio di fogli. Davanti a lui, Virginia, la moglie di Severo, morto due giorni prima.
“Ciao Virginia, come mai …”
“Signor Rossi – fece l’uomo che, dal camice bianco, doveva essere un dottore – si accomodi. Ha idea per quale motivo lei è stato convocato? – continuò, dopo che mi ero seduto sull’altra sedia che stava davanti alla scrivania. – Lei potrebbe essere accusato – fece, prima che potessi connettere – di omicidio colposo.
Guardai smarrito prima lui, poi Virginia. “Ma cosa state dicendo …”
“La qui presente signora Virginia Belotti ha deciso di denunciarla come responsabile della morte di suo marito, Severo Ignazi, ed io, come suo consulente, sto vagliando la fondatezza dell’accusa.”
“State scherzando?”
“Nient’affatto! L’autopsia ha dimostrato che l’Ignazi è morto per un collasso dovuto al diabete. E sa cosa hanno trovato nello stomaco?” Feci “no” con la testa. Ma mentivo, perché sapevo benissimo come se n’era andato il mio caro amico di una vita, Ignazi Severo. E lo sapeva ugualmente bene anche Giulio Benincasa, componente del terzetto di mattacchioni che aveva animato la vita notturna di Cittadella.
Eravamo arrivati ad oltrepassare la terza età sempre assieme: di giorno, irreprensibili professionisti, di notte, banda di sregolati, dediti a tutte le marachelle che non eravamo riusciti a fare in gioventù, quando genitori e università ci avevano costretti in binari irreprensibili. Uno degli scherzi più terribili era quello di entrare in un bar affollato, sederci al banco, fissare una persona presente e poi cominciare a parlarci negli orecchi, ammiccando a quello che avevamo individuato. Di solito puntavamo uno grosso, un po’ bradipo. Quando questo cominciava a guardarci, irritato e preoccupato, lasciavamo lentamente il locale e, prima di uscire, uno di noi si girava e gli indirizzava un gesto minaccioso con la mano. Le risate! E via di questo passo, per tante notti. La baldoria finì quando Severo cominciò a stare male. Poi, una settimana prima, aveva avuto un brutto attacco; all’ospedale ci dissero che non gli restava molto da vivere. Andammo a trovarlo la domenica mattina; lo facemmo ridere fino alle lacrime. Prima di lasciarci, in nome delle nostra amicizia, ci ordinò di accontentarlo per l’ultima volta. Al lunedì sera, eravamo da lui. Aspettammo la fine del giro della caposala prima di metterci in azione: Giulio faceva il palo mentre io gli alzavo lo schienale del letto e gli preparavo la cena sul portavivande: un paio di ostriche, qualche scampo crudo, un cucchiaio di tartara di tonno e, per finire, alici marinate, la sua passione. Alla luce soffusa per la notte, lo guardai gustare con calma ogni boccone. Bevemmo un paio di bicchieri di prosecco, assieme a Giulio, che era venuto vicino a noi. Sparecchiammo in un attimo; lo baciammo e gli augurammo buona notte. Prima di uscire, sentimmo la sua voce: “Mario, Giulio. Grazie!” Il giorno dopo se ne era andato. “Virginia – le dissi, guardandola negli occhi. – non hai mai capito niente nella vita. Quando mai capirai qualcosa anche nella morte.” Me ne andai lentamente, senza salutare la Rottenmeier.
Flavio Bisson