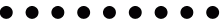Se ne fanno circa 10 milioni di pezzi DOP ogni anno in 189 aziende e se ne esporta circa il 20%. Si realizzano seguendo un processo ricco di tradizione e di conoscenze accumulate nei secoli, fino a divenire un prodotto simbolo di quella “food valley” parmigiana nella quale le antiche tradizioni del cibo contribuiscono ad illuminare il piacere dei sensi e costituiscono un linguaggio non banale nel quale, come diceva Lévi-Strauss,“una società traduce inconsciamente la sua struttura”. Nel Parmigiano il maiale viene chiamato“al nimel”, l’animale in senso assoluto (e questo la dice lunga sulla sua importanza nell’economia cortiva) e se è vero che da sempre è stato fra i principali alimenti dell’uomo è anche da sottolineare come il prosciutto, inteso in senso moderno, non ha più di cento anni. Bisogna ricordarsi che il peso dei maiali, ancora alla metà dell’800 non superava i 70 chili e le cosce pesavano attorno ai 5 chili (a volte anche 3) il che lascia pensare che il consumo fosse dopo cottura. Solo con l’intervento di nuove razze allevate (large Withe, Landrace etc) che sostituirono i ceppi locali a tinta nera, crebbe il peso e la possibilità di fare prosciutti significativi. Il terzo elemento caratterizzante della grande diffusione del prosciutto fu l’affettatrice che lo rese un prodotto della “socialità”, facendolo uscire dallo stampo contadino, potendosi comprare in bottega. Terminò così l’autoconsumo ed il prosciutto entrò, sia pur gradatamente, nel mondo della grande distribuzione.
 Niente a che vedere con la sagoma da tacco a spillo del San Daniele né con la pepata asciuttezza di quello toscano. Il prosciutto di Parma si distingue già, a prima vista, dalla forma, rigorosamente a coscia di pollo. Beninteso, gamboni tondi e rosa da 15 a 18 chili di maiali “pesanti” italiani di razze ben definite e di dieci regioni centro-settentrionali, di peso oltre i 150 kg dalla alimentazione rigidamente controllata. E poi una lavorazione semplice e ripetuta da secoli: accurata rifilatura, quasi una firma riconoscibile, poi salatura con sale marino vergine, possibilmente macinato in stabilimento, massaggi, ripulitura dal sale, riposo un poco piatto ed un poco appeso, toelettatura ed asciugatura. Sono passati tre mesi ed ora può iniziare una stagionatura lenta, dolce, senza sbalzi, interrotta da periodici interventi di “sugnatura”, di modo che questo poco di grasso tenga morbida la parte magra non protetta dalla cotenna. Qui, nel suo territorio d’origine, a sud della Via Emilia per arrivare fino agli Appennini, ad una altitudine di 900 metri, delimitato ad ovest dal torrente Stirone e a est dal fiume Enza, in questo rettangolo d’oro, sono gli stabilimenti di stagionatura, grandi parallelepipedi moderni con finestre alte e strette per facilitare la ventilazione, tutti orientati in modo trasversale rispetto al flusso di vento che scende dalle colline. L’aria che arriva dal mare della Versilia si asciuga scavalcando l’Appennino, si profuma gradatamente con i balsami degli ulivi e dei pini prima, dei boschi di castagne e di querce poi. Catturata da queste grandi finestre quell’aria aiuta i processi enzimatici e di trasformazione biochimica che sono alla base della maturazione del prosciutto. Ma stagionare un prosciutto non è come seccare un merluzzo! Non si può pensare di lasciarlo sedici mesi nella stessa posizione aspettando che maturi. E allora l’aria va governata ed anche l’aria condizionata, che oggi tutti usano, va utilizzata con giudizio e sapienza. Ma tutto è molto empirico, legato alla propria conoscenza, alla propria esperienza. La trasformazione delle stagioni ha complicato ancor di più le cose e aprire, serrare, spalancare, lasciar filtrare o attenuare il flusso d’aria richiede l’istinto e l’esperienza di chi, un tempo, sapeva leggere il cielo. E, sopra qualsiasi cosa, resta la bontà della carne per che è sempre più difficile trovare in maiali che raggiungano i nove mesi ed il 160-180 chili, geneticamente progettati, purtroppo, per essere magri. Perché è il grasso che dà sapore al prosciutto ed ora la carne, giovane è piena d’acqua. Il calo di peso di un prosciutto è circa del 30%, contro il 6/8% di prima della guerra. Solo sapendo governare quel calo si fa un buon prosciutto. Così il meglio di un prosciutto lo si ottiene attorno ai 18 mesi se il peso finale è di 10 kg, sui 2 anni se è di 11-12 chili. Così il “dolce” di Parma deriva dall’ottimale equilibrio originale fra parti magre e parti grasse delle cosce e dalle pecurialità del clima che, grazie alla non elevata umidità, consente una salagione molto leggera. Dopo 12 mesi riceve l’incoronazione, la Corona Ducale a cinque stelle, testimonianza di un prodotto di grande rilievo gastronomico, controllato più volte, nella sua vita, dal Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma. Se potete e se avete mano felice, e superate la sicura comodità di chi ve lo affetta tutto uguale preciso, tagliatelo con una coltellina, affilata e sottile, per seguire le fibre dei muscoli e ne potrete cogliere insieme la delicatezza intensa, profonda, non zuccherosa, la consistenza della carne. Accompagnatelo con pane bianco e null’altro. Cosa bere? Niente lambrusco: si sposa benissimo con bianchi a bollicine. Allora berremo fresca Malvasia secca di Parma o di Piacenza o un Franciacorta Satin Ca’ del Bosco. Se preferite una vigorosa freschezza non esitate davanti ad un Riserva Giulio Ferrari. Lasciamo stare lo Champagne: andrebbe benone, ma abbiamo bollicine stupende anche noi…
Niente a che vedere con la sagoma da tacco a spillo del San Daniele né con la pepata asciuttezza di quello toscano. Il prosciutto di Parma si distingue già, a prima vista, dalla forma, rigorosamente a coscia di pollo. Beninteso, gamboni tondi e rosa da 15 a 18 chili di maiali “pesanti” italiani di razze ben definite e di dieci regioni centro-settentrionali, di peso oltre i 150 kg dalla alimentazione rigidamente controllata. E poi una lavorazione semplice e ripetuta da secoli: accurata rifilatura, quasi una firma riconoscibile, poi salatura con sale marino vergine, possibilmente macinato in stabilimento, massaggi, ripulitura dal sale, riposo un poco piatto ed un poco appeso, toelettatura ed asciugatura. Sono passati tre mesi ed ora può iniziare una stagionatura lenta, dolce, senza sbalzi, interrotta da periodici interventi di “sugnatura”, di modo che questo poco di grasso tenga morbida la parte magra non protetta dalla cotenna. Qui, nel suo territorio d’origine, a sud della Via Emilia per arrivare fino agli Appennini, ad una altitudine di 900 metri, delimitato ad ovest dal torrente Stirone e a est dal fiume Enza, in questo rettangolo d’oro, sono gli stabilimenti di stagionatura, grandi parallelepipedi moderni con finestre alte e strette per facilitare la ventilazione, tutti orientati in modo trasversale rispetto al flusso di vento che scende dalle colline. L’aria che arriva dal mare della Versilia si asciuga scavalcando l’Appennino, si profuma gradatamente con i balsami degli ulivi e dei pini prima, dei boschi di castagne e di querce poi. Catturata da queste grandi finestre quell’aria aiuta i processi enzimatici e di trasformazione biochimica che sono alla base della maturazione del prosciutto. Ma stagionare un prosciutto non è come seccare un merluzzo! Non si può pensare di lasciarlo sedici mesi nella stessa posizione aspettando che maturi. E allora l’aria va governata ed anche l’aria condizionata, che oggi tutti usano, va utilizzata con giudizio e sapienza. Ma tutto è molto empirico, legato alla propria conoscenza, alla propria esperienza. La trasformazione delle stagioni ha complicato ancor di più le cose e aprire, serrare, spalancare, lasciar filtrare o attenuare il flusso d’aria richiede l’istinto e l’esperienza di chi, un tempo, sapeva leggere il cielo. E, sopra qualsiasi cosa, resta la bontà della carne per che è sempre più difficile trovare in maiali che raggiungano i nove mesi ed il 160-180 chili, geneticamente progettati, purtroppo, per essere magri. Perché è il grasso che dà sapore al prosciutto ed ora la carne, giovane è piena d’acqua. Il calo di peso di un prosciutto è circa del 30%, contro il 6/8% di prima della guerra. Solo sapendo governare quel calo si fa un buon prosciutto. Così il meglio di un prosciutto lo si ottiene attorno ai 18 mesi se il peso finale è di 10 kg, sui 2 anni se è di 11-12 chili. Così il “dolce” di Parma deriva dall’ottimale equilibrio originale fra parti magre e parti grasse delle cosce e dalle pecurialità del clima che, grazie alla non elevata umidità, consente una salagione molto leggera. Dopo 12 mesi riceve l’incoronazione, la Corona Ducale a cinque stelle, testimonianza di un prodotto di grande rilievo gastronomico, controllato più volte, nella sua vita, dal Consorzio di Tutela del Prosciutto di Parma. Se potete e se avete mano felice, e superate la sicura comodità di chi ve lo affetta tutto uguale preciso, tagliatelo con una coltellina, affilata e sottile, per seguire le fibre dei muscoli e ne potrete cogliere insieme la delicatezza intensa, profonda, non zuccherosa, la consistenza della carne. Accompagnatelo con pane bianco e null’altro. Cosa bere? Niente lambrusco: si sposa benissimo con bianchi a bollicine. Allora berremo fresca Malvasia secca di Parma o di Piacenza o un Franciacorta Satin Ca’ del Bosco. Se preferite una vigorosa freschezza non esitate davanti ad un Riserva Giulio Ferrari. Lasciamo stare lo Champagne: andrebbe benone, ma abbiamo bollicine stupende anche noi…
Alfredo Pelle