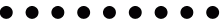Ottobre è il mese che i poeti definiscono “noioso”. Ma i poeti, si sa, fanno parte di una razza umana particolare: spesso sono tristi, hanno il vizio di lamentarsi, sono predisposti al pianto e – soprattutto – non hanno un bel rapporto con il cibo. Quasi che il piacere e la felicità del gusto siano rivali dell’ispirazione. Io che poeta non sono, graziaddìo, ho mille motivi per perdermi nell’orto e nel frutteto o tra le bancarelle del mercato. Subisco il fascino della pera e del cachi, la scontrosità dei À chi d’India e la malizia delle nespole. Sono sedotto dai sedani, tentato dai fagioli e dai porri… i peperoni mi abbagliano. Sul banco del pesce resto incerto tra lo sgombro, la sardina, il merluzzo e il pesce-persico, che non sia quello insulso e inconsistente che arriva dall’Africa. Per non parlare dei tartufi. Bianchi come cosce di monaca, profumati À no a stordire ma dannatamente cari. Meglio perdersi tra le cassette e i cesti di funghi che questo mese, “noioso” per i poeti ma appassionante per noi golosi, ci regala con infinite variazioni sul tema. Potrei fingere di essere un esperto micologo e raccontare funghi enormi trovati nei boschi, all’alba, sfidando le ingiurie del tempo e quelle dell’età… Invece io i funghi li ho raccolti poche volte e con esiti quasi sempre modesti.
Ottobre è il mese che i poeti definiscono “noioso”. Ma i poeti, si sa, fanno parte di una razza umana particolare: spesso sono tristi, hanno il vizio di lamentarsi, sono predisposti al pianto e – soprattutto – non hanno un bel rapporto con il cibo. Quasi che il piacere e la felicità del gusto siano rivali dell’ispirazione. Io che poeta non sono, graziaddìo, ho mille motivi per perdermi nell’orto e nel frutteto o tra le bancarelle del mercato. Subisco il fascino della pera e del cachi, la scontrosità dei À chi d’India e la malizia delle nespole. Sono sedotto dai sedani, tentato dai fagioli e dai porri… i peperoni mi abbagliano. Sul banco del pesce resto incerto tra lo sgombro, la sardina, il merluzzo e il pesce-persico, che non sia quello insulso e inconsistente che arriva dall’Africa. Per non parlare dei tartufi. Bianchi come cosce di monaca, profumati À no a stordire ma dannatamente cari. Meglio perdersi tra le cassette e i cesti di funghi che questo mese, “noioso” per i poeti ma appassionante per noi golosi, ci regala con infinite variazioni sul tema. Potrei fingere di essere un esperto micologo e raccontare funghi enormi trovati nei boschi, all’alba, sfidando le ingiurie del tempo e quelle dell’età… Invece io i funghi li ho raccolti poche volte e con esiti quasi sempre modesti.
I boschi in salita sono una fatica di cui faccio a meno, l’umidità mi infastidisce, non mi fido delle mie poche nozioni micologiche e poi… c’è chi lo fa per mestiere e meglio di me. Quindi i funghi li compro, pagandomi il tempo che non ho e la fatica che risparmio. Che io sia pigro non vuol dire che la ricerca e la raccolta dei funghi non sia un meritato piacere per milioni di persone ogni anno. Una coppia di amici con cui ho trascorso una vacanza in Alto Adige si svegliava ogni giorno prima dell’alba per perdersi nei boschi, farsi pungere dai tafani, sudare arrancando su pendii impraticabili, strapparsi camicie e pantaloni tra i rovi. Tornavano a casa a metà mattinata con quattro miseri esemplari di un “qualcosa” di indefinito e indegno che aveva parvenza di fungo e che immancabilmente veniva lasciato sul davanzale esterno di casa sperando che il diavolo se lo portasse. Il loro appetito veniva soddisfatto, ovviamente, dal frutto del mio lavoro mattutino: chilate di tagliatelle fresche ai porcini, comprati dal fruttivendolo del paese. Resta il fatto che molti, ancora oggi, prendono sul serio le leggende ritenute “infallibili” per distinguere un buon fungo selvatico da uno cattivo: una moneta o un cucchiaino d’argento non diventano neri solo durante la cottura di funghi velenosi; l’aglio o la cipolla (sempre tenuti in grande considerazione per i loro poteri antimalefici) non anneriscono a contatto con esemplari tossici, le lumache o le formiche mangiano anche le specie pericolose. Nessuna di queste affermazioni si basa su verità scientifiche. Un consiglio prezioso per i martiri-del-bosco è quello di “specializzarsi” in tre o quattro tipologie di funghi come i porcini, i cantarelli e gli ovoli. Gli altri meglio lasciarli ai cercatori più informati. Solo la pratica, l’esperienza e un esperto micologo possono scongiurare un tragico dopocena. E quando un fungo appare sospetto, il miglior consiglio e non raccoglierlo ma lasciarlo dove il buondìo l’ha messo, evitando di distruggerlo per non alterare l’equilibrio del bosco. Dicevo poco fa che i funghi io non li raccolgo ma mi scordavo di dire che non li mangio. Non più, da quando scoprii di essere stato colpito – dopo trent’anni passati a pascermi di funghi preparati in tutti i modi e a ogni latitudine – da un improvviso deficit dell’enzima trialasi, una proteina che permette all’organismo umano di “smontare” e rendere digeribile il trealosio, uno zucchero complesso prodotto e utilizzato dai funghi come protettore strutturale. Un dramma culinario che mi tiene, da vent’anni, in perenne crisi da privazione ma che non mi impedirà, nemmeno questo ottobre, di riempirmi la cucina di funghi, la sala da pranzo di amici e le narici di profumi sublimi. Soffrirò moltissimo, lo so, ma i miei crostoni ai finferli, il mio risotto ai porcini, le mie insalate di ovoli e tartufo, la mia zuppa di funghi con vongole e calamari, la mia parmigiana di mazze da tamburo e soprattutto il mio coniglio con le russole dorate, sono pezzi di vita e di storia personale di cui non so fare a meno. Me li devo. Girerò i mercati di Roma, dell’Umbria e della Toscana per procacciarmi i funghi più degni, che preparerò in scontrosa solitudine limitandomi a gustarli solo col naso e con l’occhio. Li palperò con voluttà, li fiuterò con libidine e li affetterò con passione. Li guarderò struggersi di felicità nell’olio del Garda o in quello di Cartoceto, e mi commuoverò di gioia fissandoli mentre si fondono assieme alle carni e alle verdure formando guazzetti densi e corposi color dell’oro. Mi basta. Deve bastarmi, vita ingrata! Vabbene, asciugo la lacrima e smetto di atteggiarmi a poeta sfigato e lagnoso. Per un risultato perfetto, tutti i funghi vanno cucinati entro poche ore dalla raccolta. Al limite, per un giorno, massimo due, è possibile lasciarli in frigo, nella parte bassa, dentro un sacchetto di carta o un involto di canapa: nelle buste di plastica sarebbero aggrediti dalle muffe entro un paio d’ore. Dura a morire la credenza che vuole che i funghi non vadano lavati ma solo raschiati. Purtroppo per chi crede a questa baggianata è scientificamente dimostrato che la struttura del fungo non riesce ad assorbire la minima quantità d’acqua e quindi non perde né gusto né nutrienti. Qualche minuto d’ammollo in acqua fresca e un dolce risciacquo in acqua corrente può scongiurare noiose parassitosi, soprattutto se i funghi provengono da aree in cui pascolano cinghiali o cervi. Tutti i funghi sono creature delicate e sensibili; mal sopportano i condimenti importanti e rifiutano con sdegno la vicinanza con la cipolla che ne guasta il gusto e l’aroma. Per trifolare porcini, ovoli, galletti e chiodini è opportuno scegliere tegami di coccio con coperchio, al cui “calor dolce” i funghi esaleranno lentamente l’umidità dentro la quale si cuoceranno. La trifolatura è indicata per finferli, chiodini, porcini, trombette (craterellus). Dovrebbe essere eseguita con esemplari freschi, sodi e profumati, affettati a spessore di 3 millimetri. Nel tegame far scaldare poco olio extravergine, dar colore (non bruciare!) all’immancabile spicchio d’aglio schiacciato, adagiare i funghi e lasciarli cuocere sotto coperchio nella loro acqua a fuoco basso. Ultimare con un trito di prezzemolo a fuoco spento. Per le specie con carni viscide o spugnose, i lattarini e le russule, è indicata la frittura veloce in olio (sempre extravergine) a temperatura superiore ai 170°. La cottura alla griglia è ideale per i funghi più carnosi e profumati (porcini, ovoli, mazze da tamburo). Meglio evitare le cotture veloci e superficiali che possono carbonizzare le superfici rendendole tossiche e aumentare la già difficile digeribilità dei funghi. Brace non altissima e qualche incisione in più punti consentono al calore di penetrare all’interno ed evitano al fungo di trasformarsi in un mattone digestivo. Concludo con una nota enologica. I funghi non vanno molto d’accordo con i vini rossi “di corpo” né con quelli con tendenza troppo acida. Si valorizzano invece con i vini bianchi morbidi, maturi, che profumano di frutta. Gli Chardonnay e i Pinot Bianchi ne esaltano la delicata fragranza. Anche i vini rosati fruttati e delicati possono essere abbinati a salse di funghi come nel caso di una pasta con porcini. L’abbinamento “giusto” – ma la prima regola da rispettare è il gusto personale – è quello che mette assieme cibo e vino con la stessa intensità sia in bocca che al naso: più la pietanza (fungo+condimento) è ricca di profumo-aroma più richiede di essere abbinata a un vino di pari importanza.
Sergio G. Grasso