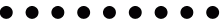Una manciata di semi amidacei e farinosi rappresenta da sempre una garanzia di sopravvivenza per chi lotta ogni giorno contro i morsi della fame. Umili graminacee come avena, farro, sorgo, orzo, frumento, non hanno solo guidato Homo sapiens fuori dalla preistoria ma – più tardi anche con l’arrivo di mais e riso – forti del loro valore nutrizionale e ancor più di un elevato potere saziante, hanno edificato una straordinaria corrente geo-culinaria fatta di contaminazioni e ibridazioni alimentari con l’Estremo Oriente, l’Africa, le Americhe e il Nordeuropa. E noi siamo parte di questo meticciato gastronomico che si esprime in una specificità culturale fatta di forme diverse e sostanzialmente immutabili ottenute mescolando acqua e farina: il pane, la polenta, il cous-cous e, ovviamente, la pasta. È il caso di ricordare che l’arrivo in Italia della pasta secca – quella di grano duro – non si deve a Marco Polo che alla fine del XIII secolo rientra dalla Cina (dove il frumento era ancora poco più che una curiosità botanica) ma ai Musulmani che dal Nordafrica sbarcarono in Sicilia 500 anni prima. Ma questo non fu che l’atto finale di una storia iniziata già nel Neolitico impastando la farina di grano tenero con l’acqua. Così fu più tardi per Greci, Etruschi e Romani che si cibavano di lagànoi o làganae, le progenitrici delle nostre lasagne. A Roma dedicano attenzione a queste paste fresche anche illustri autori classici come Orazio (I secolo a.C.), Cornelio Celso e Petronio Arbitro (entrambi vissuti nel I sec. d.C.); e ovviamente Apicio, che nel suo De re coquinaria, ci tramanda la ricetta della patina cotidiana, confezionata con lasagne (sfoglie o tractae) inframmezzate da sughi a base di carne, pesce e aromi: «quotquot posueris, tot trullas impensae desuper adficies» (per quante sfoglie metterai coprile con altrettanti mestoli di condimento) e per finire «unum vero laganum fistula percuties, et superimpones» (spiana bene una sfoglia col mattarello e mettila sopra a tutto). Che dire se non che ci troviamo davanti alla ricetta completa di un “pasticcio” antico di duemila anni!? Perché pasta e condimento – dolce o salato non fa differenza – vivono insieme, si completano, si esaltano e si sostanziano in un sistema il cui valore oltrepassa quello dei singoli elementi. Il massimo risultato di questa alchimia si ottiene quando la sfoglia di pasta si appropria del suo condimento celandolo alla vista, avvolgendolo quasi a reclamarne la proprietà: due corpi uniti finchè morso non li separi. Se questo avvenga già ai tempi dell’Antica Roma non è dato sapere ma possiamo presumere che il riempire una sfoglia di pasta con i rimasugli di carni o pesci, ciuffi d’erbe o avanzi di formaggi (com’è il caso del “cacio raviggiolo” da cui deriverebbe il nostro raviolo) sia un’ancestrale conseguenza dell’istinto di parsimonia funzionale al gusto e dell’umana curiosità assistita dall’ingegno. Senza dimenticare che la fortuna di tali preparazioni ha goduto anche di due valori simbolici: l’aspetto opulento, ricco, enfatico, e l’allegoria del ventre gravido da cui si attende una nuova vita. In una pergamena del 1112 si trova l’affermazione: “tertia pars turtellorum monachorum est” (la terza parte dei tortelli spetta ai monaci) e in una bolla papale del 1169 si indicano “duas partes turtellorum”; purtroppo, al di là dell’assonanza del nome con gli attuali tortelli e tortellini (col significato di piccole torte o di forme ritorte), null’altro ci permette di definire di cosa si tratti. La traccia che ci offre Giovanni Boccaccio nel Decameron è sufficiente a farci capire che nel XIV secolo il nome “raviolo” designava una sorta di pasta cotta in brodo: “… e c’era una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale c’erano persone che non facevano altro che mangiare maccheroni e ravioli, e cuocerli in brodo di cappone”. Bisogna ricorrere al trecentesco codice 158 della Biblioteca dell’Università di Bologna per trovare delle vere e proprie ricette per “raviuoli”, “tortelli” e “tortelletti”, mentre un anonimo veneziano della fine dello stesso secolo codifica i “rafioli di carne, di herbe, cacio fresco e passo”. Lo sterminato ricettario del Belpaese declina questi contenitori di meraviglie in una ventina di modi diversi: agnolini agnolotti, anolini, cappellacci, cappelletti, casonsei cjarsons culurgiones, gobein, marubini, pansoti, ravioli, schlutzkrapfen, tortelli, tortellini, zembi…: tante quanti i dialetti se non i campanili. Ma ogni oste e ogni massaia ha il diritto sacrosanto di interpretare, togliere o aggiungere a seconda dei gusti, delle abitudini e della disponibilità di ingredienti: dalla quantità di uova nell’impasto ai tagli di carne, dalle varietà di pesce alle verdure e ai formaggi del ripieno della dimensione, del condimento e della tipologia di ottura. E se il “gusto” autorizza la scelta tra il dolce e il salato, quella tra il grasso e il magro deriva dai precetti alimentari che hanno fatto del Cristianesimo una componente fondamentale della nostra tradizione gastronomica. E non poteva essere diversamente in una religione in cui pane e vino diventano nutrimento nell’eucarestia e il cui Cristo si è congedato dal mondo durante una cena.
Una manciata di semi amidacei e farinosi rappresenta da sempre una garanzia di sopravvivenza per chi lotta ogni giorno contro i morsi della fame. Umili graminacee come avena, farro, sorgo, orzo, frumento, non hanno solo guidato Homo sapiens fuori dalla preistoria ma – più tardi anche con l’arrivo di mais e riso – forti del loro valore nutrizionale e ancor più di un elevato potere saziante, hanno edificato una straordinaria corrente geo-culinaria fatta di contaminazioni e ibridazioni alimentari con l’Estremo Oriente, l’Africa, le Americhe e il Nordeuropa. E noi siamo parte di questo meticciato gastronomico che si esprime in una specificità culturale fatta di forme diverse e sostanzialmente immutabili ottenute mescolando acqua e farina: il pane, la polenta, il cous-cous e, ovviamente, la pasta. È il caso di ricordare che l’arrivo in Italia della pasta secca – quella di grano duro – non si deve a Marco Polo che alla fine del XIII secolo rientra dalla Cina (dove il frumento era ancora poco più che una curiosità botanica) ma ai Musulmani che dal Nordafrica sbarcarono in Sicilia 500 anni prima. Ma questo non fu che l’atto finale di una storia iniziata già nel Neolitico impastando la farina di grano tenero con l’acqua. Così fu più tardi per Greci, Etruschi e Romani che si cibavano di lagànoi o làganae, le progenitrici delle nostre lasagne. A Roma dedicano attenzione a queste paste fresche anche illustri autori classici come Orazio (I secolo a.C.), Cornelio Celso e Petronio Arbitro (entrambi vissuti nel I sec. d.C.); e ovviamente Apicio, che nel suo De re coquinaria, ci tramanda la ricetta della patina cotidiana, confezionata con lasagne (sfoglie o tractae) inframmezzate da sughi a base di carne, pesce e aromi: «quotquot posueris, tot trullas impensae desuper adficies» (per quante sfoglie metterai coprile con altrettanti mestoli di condimento) e per finire «unum vero laganum fistula percuties, et superimpones» (spiana bene una sfoglia col mattarello e mettila sopra a tutto). Che dire se non che ci troviamo davanti alla ricetta completa di un “pasticcio” antico di duemila anni!? Perché pasta e condimento – dolce o salato non fa differenza – vivono insieme, si completano, si esaltano e si sostanziano in un sistema il cui valore oltrepassa quello dei singoli elementi. Il massimo risultato di questa alchimia si ottiene quando la sfoglia di pasta si appropria del suo condimento celandolo alla vista, avvolgendolo quasi a reclamarne la proprietà: due corpi uniti finchè morso non li separi. Se questo avvenga già ai tempi dell’Antica Roma non è dato sapere ma possiamo presumere che il riempire una sfoglia di pasta con i rimasugli di carni o pesci, ciuffi d’erbe o avanzi di formaggi (com’è il caso del “cacio raviggiolo” da cui deriverebbe il nostro raviolo) sia un’ancestrale conseguenza dell’istinto di parsimonia funzionale al gusto e dell’umana curiosità assistita dall’ingegno. Senza dimenticare che la fortuna di tali preparazioni ha goduto anche di due valori simbolici: l’aspetto opulento, ricco, enfatico, e l’allegoria del ventre gravido da cui si attende una nuova vita. In una pergamena del 1112 si trova l’affermazione: “tertia pars turtellorum monachorum est” (la terza parte dei tortelli spetta ai monaci) e in una bolla papale del 1169 si indicano “duas partes turtellorum”; purtroppo, al di là dell’assonanza del nome con gli attuali tortelli e tortellini (col significato di piccole torte o di forme ritorte), null’altro ci permette di definire di cosa si tratti. La traccia che ci offre Giovanni Boccaccio nel Decameron è sufficiente a farci capire che nel XIV secolo il nome “raviolo” designava una sorta di pasta cotta in brodo: “… e c’era una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale c’erano persone che non facevano altro che mangiare maccheroni e ravioli, e cuocerli in brodo di cappone”. Bisogna ricorrere al trecentesco codice 158 della Biblioteca dell’Università di Bologna per trovare delle vere e proprie ricette per “raviuoli”, “tortelli” e “tortelletti”, mentre un anonimo veneziano della fine dello stesso secolo codifica i “rafioli di carne, di herbe, cacio fresco e passo”. Lo sterminato ricettario del Belpaese declina questi contenitori di meraviglie in una ventina di modi diversi: agnolini agnolotti, anolini, cappellacci, cappelletti, casonsei cjarsons culurgiones, gobein, marubini, pansoti, ravioli, schlutzkrapfen, tortelli, tortellini, zembi…: tante quanti i dialetti se non i campanili. Ma ogni oste e ogni massaia ha il diritto sacrosanto di interpretare, togliere o aggiungere a seconda dei gusti, delle abitudini e della disponibilità di ingredienti: dalla quantità di uova nell’impasto ai tagli di carne, dalle varietà di pesce alle verdure e ai formaggi del ripieno della dimensione, del condimento e della tipologia di ottura. E se il “gusto” autorizza la scelta tra il dolce e il salato, quella tra il grasso e il magro deriva dai precetti alimentari che hanno fatto del Cristianesimo una componente fondamentale della nostra tradizione gastronomica. E non poteva essere diversamente in una religione in cui pane e vino diventano nutrimento nell’eucarestia e il cui Cristo si è congedato dal mondo durante una cena.
Finché morso non li separi
Tempo di lettura: 3 minuti
0votes