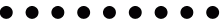Già nel paleolitico gli uomini catturavano e mangiavano pesci di fiume o di lago, come dimostrato dai ritrovamenti di resti di pasti contenenti lische e teste di pesce anche molto lontano dalle coste. In quasi tutte le località italiane dove sorgevano villaggi su palafitte prossime a fiumi o laghi sono stati trovati reperti che provano come già 6000 anni fa la pesca in acque inter ne fosse attività comune. È il caso di alcuni laghi padani, dell’umbro Trasimeno e dei laghi laziali di Bolsena e di Bracciano, dove il fondale ha restituito anche i pali di fon dazione delle abitazioni, numerosi oggetti di uso comune, ami di corno, arpioni di osso, lance, piroghe dell’età del bronzo e resti di reti da pesca con le cui annodature simili a quelle odierne. Per gli antichi Egizi e le popolazioni mesopotamiche, i fiumi (Nilo, Tigri, Eufrate) rappresentavano la principale risorsa nutritiva. Il pesce veni va pescato con reti, lance e nasse di canne intrecciate ed era venduto nei mercati, consumato fresco ma anche pulito e conserva to sotto sale per donarlo agli dei e ai defunti come offerta. Scrittori latini come Plinio, Eliano, Oppiano, Decimo o Ausonio testimoniano della grande importanza della pesca nei fiumi e nei laghi dell’Antica Roma e dell’Impero. I loro testi descrivono varie specie di pesci, la tecnica della pesca con lo “sparviero” e altri metodi di cattura, le abitudini di vita, le localizzazioni predi lette e perfino gli organi di senso di diver se specie ittiche. Con il Cristianesimo il nome greco del pesce – (ichtòs) divenne l’acrostico di “Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr” (Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore).
Nei Vangeli i riferimenti alla pesca, ai pescatori e al lago di Tiberiade sono frequenti e nell’Alto Medioevo il pesce assume la valenza di alimento “cristologico” capace di contrapporsi ai peccati della carne e in quanto tale ammesso negli oltre 200 giorni annuali di astinenza e digiuno. È opinione comune che i pesci d’acqua dolce siano generalmente meno saporiti (ovvero meno “salati”) di quelli marini. Certo, l’acqua di mare contiene mediamente il 3% di cloruro di sodio, il comune sale da cucina, ma non è questa la spiegazione del gusto più spiccato dei pesci di mare, poiché la concentrazione di sodio nelle cellule di tutti i pesci, sia di acqua dolce che salata, è inferiore all’uno per cento. I pesci marini devono compensare la pressione osmotica sulle cellule e per sopravvivere nei mari devono ingurgitare grandi quantità di acqua salata accumulando nelle cellule alcuni amminoacidi fra cui la glicina, dal sapore dolciastro, e l’acido glutammico insieme al suo sale, il glutammato (l’umami dei giapponesi), che ha il potere di esalta re i sapori e di rendere apparentemente più sapide le carni. I pesci d’acqua dolce, invece, vivendo in un ambiente povero di sodio (mediamente inferiore all’1,5%), mantengono naturalmente il loro equilibrio cellulare, non si disidratano, non devono “bere” grandi quantità d’acqua e hanno un sapore più blando in quanto non immagazzinano quelle sostanze nelle loro cellule. Se si esclude la trota, di cui siamo tra i principali produttori europei, il pesce di acqua dolce più consumato in Italia è il Lates niloticus o “Persico del Nilo”, una delle specie invasi ve più dannose al mondo. Predatore vorace e prolifico, può arrivare a due metri di lunghezza e 200 chili di peso e viene pescato nelle acque del Lago Victoria (fra Tanzania, Kenya e Uganda), notoriamente cariche di liquami, metalli pesanti e una quantità enorme di pesticidi proveniente dalle piantagioni di tè e caffè. Le sue carni sono ricche di colesterolo, povere di omega3, di gusto scialbo ma attraggono i gastro-gon zi per il colore rosato, l’assenza di spine, la dimensione dei filetti e il prezzo basso. Per farsi un’idea di come la sua pesca abbia distrutto l’assetto sociale delle popolazioni che vivono attorno al lago, basta guardare il pluripremiato film-verità di Hubert Sauper “L’incubo di Darwin”. Tra i più gettona ti pesci d’acqua dolce nel nostro paese vi è anche il pangasio (Pangasius hypophtal mus), della famiglia dei pesci gatto, allevato e pescato in Vietnam, nelle acque del delta del Mekong – tra le più inquinate a livello mondiale – e trattato con nitrati, solfiti e anidride solforosa. I suoi filetti, venduti a prezzi molto bassi, contengono molta acqua, poco grasso e sono praticamente privi sapore al punto da essere spacciati per merluzzo, ombrina o gallinella. Due parole sulla tilapia (Oreochromis spp.) il cui mag gior produttore è la Cina ed è forse il pesce più venduto al mondo poiché insapore, di rapidissima crescita e costo molto basso. A parte l’irrilevante contenuto di omega3, preoccupano le condizioni di allevamento di questo pesce non carnivoro che dovrebbe nutrirsi di alghe e piante acquatiche e che invece viene allevato con mangimi a base di scarti di pollame, carcasse animali, cascami di bestiame e persino feci umane in bacini contaminati da acque reflue, nella sporcizia generale. Per quanto i control li delle autorità italiane siano costanti ed efficaci sulla qualità sanitaria di questi tre pesci importati, personalmente li guardo con disistima e ne faccio felicemente a meno, soprattutto per le implicazioni etiche e ambientali che si celano dietro al loro allevamento e commercio. Preferisco il persico, il coregone, le tinche, i lucci del “mio” Lago di Bolsena, i “missultitt” (agoni essiccati) che mi manda Carlo dal Lago di Como, il salmerino del Lago di Tovel (TN), le trote iridee del Cordevole (BL) o della Valnerina (TR). Mi rattrista che in Italia i pesci di lago e fiume siano spesso sconosciuti, sotto-sti mati e, soprattutto nel centro-sud poco considerati dai mercati e dalla ristorazione. Se il motivo è nella delicatezza delle loro carni, meglio non svilirle con l’aggiunta di aromi, salse o intrugli vari. Basterebbe cuocerli assieme a un pezzo di alga kombu per restituire loro quel tanto di acido glutammico (umami) che Madre Natura ha voluto regalare solo al pesce di mare.