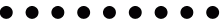Chiedo al portiere dell’albergo se nel loro ristorante si può mangiare un po’ di pesce crudo. Mi dice che loro non lo fanno; gli dico che non vorrei toccare la macchina. – Non c’è qualcosa qui vicino? Siamo a Pesaro e vicini a mare; non mi dica che non c’è un ristorante di pesce qui attorno. Mi manda al Commodoro, da Ginetto. A piedi non ci impiego molto; vedo la parte della città dedicata al turismo estivo e i molti negozi, con le luci spente mi mettono malinconia. E’ una serata di novembre, giorno feriale: non c’è tanta gente in giro. La malinconia si trasforma in cattivo umore, al pensiero di mangiare da solo. E il cattivo umore diventa incazzatura perché mi torna in mente quello stronzo che mi ha fatto fare cento chilometri in più per poi dirmi che non poteva ricevermi e che fissassi un altro appuntamento. Insomma quando metto piede nel Commodoro ho le palle girate. Una volta seduto al tavolo, tanto per non stare lì a guardare le pareti, chiedo al giovane cameriere se ricevono Zafferano. Dice che non sa e andrà a chiedere in cucina; cerco di fermarlo ma è già sparito. Non passa un minuto che arriva un altro cameriere, che dev’essere il capo sala e m’informa, seccato, che loro non mettono lo zafferano nel pesce e mi chiede se ho deciso cosa mangiare. Adesso sono cotto a puntino: basterebbe uno spillo per farmi scoppiare. – Sì – dico – ho scelto. Mi porti uno stracchino. – Come? – Uno stracchino, una crescenza, una certosa, come lo chiamate qui? Non passa un minuto che arriva Ginetto, lo capisco dall’aria e dal grembiule nero che porta solo lui. Mi mette sul tavolo un piattino su cui troneggia un candido stracchino, morbido, liquefacente. Mi fissa negli occhi e mi dice: – Questo è il suo stracchino, questo è il conto, quella è l’uscita. Prima se ne va, meglio è.
ACHTUNG GINETTO
Tempo di lettura: 1 minuto
0votes