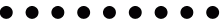Nei climi temperati molte piante perenni hanno aumentato le dimensioni del loro apparato radicale – o della porzione sotterranea del fusto, nel caso dei tuberi – trasformandolo in un ampio deposito dove stoccare gli elementi nutritivi per sopravvivere d’inverno e dare inizio alla fioritura in primavera. Queste scorte nutritive della pianta, composte da carboidrati complessi (amidi), sali minerali, fibre (inulina) e vitamine idrosolubili, sono da tempo immemorabile – e con grande vantaggio – usate per finalità alimentari anche dagli animali e dall’uomo. Tuttavia, a dispetto della loro enorme utilità alimentare, radici, tuberi e rizomi commestibili non hanno goduto per millenni di alta reputazione sulle tavole borghesi o nobiliari: nascevano sottoterra, nel buio regno dei morti ed erano ritenuti espressione delle divinità infernali. Il favore degli antichi “palati fini” andava soprattutto alle verdure a foglia, alle bacche, alla frutta, ai fiori e alle erbe che crescevano alla luce del sole, così come, ovviamente, agli animali che pascolavano o scorrazzavano all’aria aperta, in boschi e praterie e non a quella che dimorava in anfratti e buche del terreno, come i conigli, i ricci, i tassi e i serpenti. Non a caso i nobili di Roma antica, della Grecia di Pericle, dell’Egitto di Tutankhamon e dei Persiani di Dario, aborrivano l’aglio e la cipolla – ancora oggi evitati come la peste da molti pervenues, immemori del fatto che senza i due preziosi bulbi non esisterebbe l’intera cucina del Mediterraneo – i porri e le rape, le carote e perfino i tartufi, colpevoli solo di prender vita e svilupparsi lontani dal sole. Così fu nel Medioevo, quando radici, tuberi e rizomi erano ostinatamente relegati al truogolo dei maiali e alla tavola dei diseredati, degli Zanni e dei Bertoldi d’Europa. Poco cambiò fino agli anni ’70 del secolo scorso, quando una nuova coscienza alimentare, la riscoperta non più imbarazzata della cucina popolare e il bisogno di riappropriarsi di quel poco di terra sfuggita all’industria e alla “rivoluzione verde”, permisero alle umili radici e ai tuberi d’antan di guadagnarsi una dignitosa posizione anche nel mondo della ristorazione di qualità. Per quanto i botanici distinguano le radici dai tuberi, dai cormi, dai bulbi e dalle radici tuberose, i libri di cucina includono sotto la voce “radici” molte varietà che botanicamente sono ben altro. Tra le vere radici – come carota, barbabietola, ravanello, rapa, pastinaca, rafano ecc – ve ne sono però molte quasi ignote al mercato europeo fino a qualche anno fa, nonostante la loro storia culinaria nei paesi d’origine sia più che millenaria. Solo da una decina d’anni in Italia si trova, soprattutto nei negozi di prodotti etnici una preziosa radice mesoamericana, probabilmente la prima ad essere esportata dopo Colombo in altri continenti: la manioca (Manihot esculenta) nota anche come “cassava” o “yuca”; originaria del Brasile, coltivata dai Maya 15 secoli fa e diffusissima anche in Africa e Asia, è tra i primi cibi-base del mondo grazie al suo alto valore energetico; al palato è piuttosto neutra, delicata, con una nota giudiziosamente amarognola; si consuma solo previa cottura oppure si trasforma in quel diffuso sfarinato amidaceo chiamato “tapioca”. Dalle Ande peruviane e colombiane arriva anche una delle più antiche piante coltivate in Sudamerica, la “arracacha” (Arracacia xanthorrhiza) la cui preziosa radice amidacea assomiglia a una tozza carota dalla polpa gialla o viola con un sapore che ricorda il sedano-rapa, il cavolo e castagna; dotata di una finissima granulosità degli amidi si adatta anche alla nutrizione di bambini e anziani. Sempre in quell’area si coltiva e consuma la Pachyrhizus erosus o “jicama”, una pianta rampicante che produce una radice globosa a polpa bianca, dolciastra, croccante e succosa; il suo nome in lingua nàhuatl significa infatti “radice acquosa”; generalmente si consuma cruda oppure cotta al vapore, in forno o fritta e ha la caratteristica di assorbire i sapori degli ingredienti con cui si accompagna. Al peruviano Lepidium meyenii o “maca”, arride un buon successo sui mercati europei e statunitensi grazie alle proprietà depuranti, ricostituenti e afrodisiache delle sue radici, consumabili sia fresche, sia in polvere: una specie di “ginseng delle Ande” di cui, pare, si cibassero anche i guerrieri imperiali Inca. Dall’antichissima cultura aborigena arriva l’Ipomea costata o “rock morning”, una varietà di patata dolce australiana che ha profondi significati totemici e mitologici per i nativi al punto di essere raffigurata su pitture e graffiti antichi di millenni; il suo gusto dolciastro e la consistenza pastosa ricordano sia la patata che la zucca. Gli aborigeni, ma non solo, consumano anche – arrostite, lessate, cotte a vapore, fritte o ridotte in purea – le radici acquatiche di “cumbungi” o “bulrush” (Typha domingensis), zuccherose, ricche di carboidrati e sali minerali. L’Asia è la patria del “taro” (Colocasia esculenta) adattatosi meravigliosamente ai climi e alle abitudini gastronomiche di molte nazioni sudamericane, africane, asiatiche e del Pacifico. Si tratta di una radice molto versatile dalla buccia scura e interno violaceo; poco amidacea, si prepara bollita, arrostita, fritta o stufata in padella, in purea, stufata o fritta e non è edibile cruda. Utilizzata da migliaia di anni nella cucina popolare della Cina, è un perfetto sostituto della patata; celebri anche le preparazioni a base di taro come l’Hawajan Poi e la Zuppa Coreana. Per concludere questo piccolo ed enormemente incompleto inventario di radici esotiche e poco considerate dalla gastronomia italiana ed europea, ecco il “daikon” (Raphanus sativus), una grossa radice nipponica, quasi una carota bianca, che ha avuto da noi una certa fortuna come materiale per le sculture vegetali ma che in realtà può essere annoverata tra i super-food: drenante e diuretica, accelera il metabolismo e funziona da brucia-grassi naturale accelerando il metabolismo. Si consuma cruda come le carote oppure al vapore, gratinata, fritta o ridotta in vellutata; il gusto è pungente come il ravanello o lo zenzero e diventa meno piccante verso la parte sommitale. Una considerazione finale: le radici edibili rappresentano dovunque un patrimonio alimentare ereditato dalle generazioni passate, una fantastica ricchezza biologica e culturale che merita conoscere e sperimentare con umiltà e buon senso, senza improvvisazione. Ma anche un modo gioioso per entrare in contatto con saperi antichi e lontani, storia e storie: radici che si intrecciano tra la terra e la tavola, i simboli, i miti e i riti.
Nei climi temperati molte piante perenni hanno aumentato le dimensioni del loro apparato radicale – o della porzione sotterranea del fusto, nel caso dei tuberi – trasformandolo in un ampio deposito dove stoccare gli elementi nutritivi per sopravvivere d’inverno e dare inizio alla fioritura in primavera. Queste scorte nutritive della pianta, composte da carboidrati complessi (amidi), sali minerali, fibre (inulina) e vitamine idrosolubili, sono da tempo immemorabile – e con grande vantaggio – usate per finalità alimentari anche dagli animali e dall’uomo. Tuttavia, a dispetto della loro enorme utilità alimentare, radici, tuberi e rizomi commestibili non hanno goduto per millenni di alta reputazione sulle tavole borghesi o nobiliari: nascevano sottoterra, nel buio regno dei morti ed erano ritenuti espressione delle divinità infernali. Il favore degli antichi “palati fini” andava soprattutto alle verdure a foglia, alle bacche, alla frutta, ai fiori e alle erbe che crescevano alla luce del sole, così come, ovviamente, agli animali che pascolavano o scorrazzavano all’aria aperta, in boschi e praterie e non a quella che dimorava in anfratti e buche del terreno, come i conigli, i ricci, i tassi e i serpenti. Non a caso i nobili di Roma antica, della Grecia di Pericle, dell’Egitto di Tutankhamon e dei Persiani di Dario, aborrivano l’aglio e la cipolla – ancora oggi evitati come la peste da molti pervenues, immemori del fatto che senza i due preziosi bulbi non esisterebbe l’intera cucina del Mediterraneo – i porri e le rape, le carote e perfino i tartufi, colpevoli solo di prender vita e svilupparsi lontani dal sole. Così fu nel Medioevo, quando radici, tuberi e rizomi erano ostinatamente relegati al truogolo dei maiali e alla tavola dei diseredati, degli Zanni e dei Bertoldi d’Europa. Poco cambiò fino agli anni ’70 del secolo scorso, quando una nuova coscienza alimentare, la riscoperta non più imbarazzata della cucina popolare e il bisogno di riappropriarsi di quel poco di terra sfuggita all’industria e alla “rivoluzione verde”, permisero alle umili radici e ai tuberi d’antan di guadagnarsi una dignitosa posizione anche nel mondo della ristorazione di qualità. Per quanto i botanici distinguano le radici dai tuberi, dai cormi, dai bulbi e dalle radici tuberose, i libri di cucina includono sotto la voce “radici” molte varietà che botanicamente sono ben altro. Tra le vere radici – come carota, barbabietola, ravanello, rapa, pastinaca, rafano ecc – ve ne sono però molte quasi ignote al mercato europeo fino a qualche anno fa, nonostante la loro storia culinaria nei paesi d’origine sia più che millenaria. Solo da una decina d’anni in Italia si trova, soprattutto nei negozi di prodotti etnici una preziosa radice mesoamericana, probabilmente la prima ad essere esportata dopo Colombo in altri continenti: la manioca (Manihot esculenta) nota anche come “cassava” o “yuca”; originaria del Brasile, coltivata dai Maya 15 secoli fa e diffusissima anche in Africa e Asia, è tra i primi cibi-base del mondo grazie al suo alto valore energetico; al palato è piuttosto neutra, delicata, con una nota giudiziosamente amarognola; si consuma solo previa cottura oppure si trasforma in quel diffuso sfarinato amidaceo chiamato “tapioca”. Dalle Ande peruviane e colombiane arriva anche una delle più antiche piante coltivate in Sudamerica, la “arracacha” (Arracacia xanthorrhiza) la cui preziosa radice amidacea assomiglia a una tozza carota dalla polpa gialla o viola con un sapore che ricorda il sedano-rapa, il cavolo e castagna; dotata di una finissima granulosità degli amidi si adatta anche alla nutrizione di bambini e anziani. Sempre in quell’area si coltiva e consuma la Pachyrhizus erosus o “jicama”, una pianta rampicante che produce una radice globosa a polpa bianca, dolciastra, croccante e succosa; il suo nome in lingua nàhuatl significa infatti “radice acquosa”; generalmente si consuma cruda oppure cotta al vapore, in forno o fritta e ha la caratteristica di assorbire i sapori degli ingredienti con cui si accompagna. Al peruviano Lepidium meyenii o “maca”, arride un buon successo sui mercati europei e statunitensi grazie alle proprietà depuranti, ricostituenti e afrodisiache delle sue radici, consumabili sia fresche, sia in polvere: una specie di “ginseng delle Ande” di cui, pare, si cibassero anche i guerrieri imperiali Inca. Dall’antichissima cultura aborigena arriva l’Ipomea costata o “rock morning”, una varietà di patata dolce australiana che ha profondi significati totemici e mitologici per i nativi al punto di essere raffigurata su pitture e graffiti antichi di millenni; il suo gusto dolciastro e la consistenza pastosa ricordano sia la patata che la zucca. Gli aborigeni, ma non solo, consumano anche – arrostite, lessate, cotte a vapore, fritte o ridotte in purea – le radici acquatiche di “cumbungi” o “bulrush” (Typha domingensis), zuccherose, ricche di carboidrati e sali minerali. L’Asia è la patria del “taro” (Colocasia esculenta) adattatosi meravigliosamente ai climi e alle abitudini gastronomiche di molte nazioni sudamericane, africane, asiatiche e del Pacifico. Si tratta di una radice molto versatile dalla buccia scura e interno violaceo; poco amidacea, si prepara bollita, arrostita, fritta o stufata in padella, in purea, stufata o fritta e non è edibile cruda. Utilizzata da migliaia di anni nella cucina popolare della Cina, è un perfetto sostituto della patata; celebri anche le preparazioni a base di taro come l’Hawajan Poi e la Zuppa Coreana. Per concludere questo piccolo ed enormemente incompleto inventario di radici esotiche e poco considerate dalla gastronomia italiana ed europea, ecco il “daikon” (Raphanus sativus), una grossa radice nipponica, quasi una carota bianca, che ha avuto da noi una certa fortuna come materiale per le sculture vegetali ma che in realtà può essere annoverata tra i super-food: drenante e diuretica, accelera il metabolismo e funziona da brucia-grassi naturale accelerando il metabolismo. Si consuma cruda come le carote oppure al vapore, gratinata, fritta o ridotta in vellutata; il gusto è pungente come il ravanello o lo zenzero e diventa meno piccante verso la parte sommitale. Una considerazione finale: le radici edibili rappresentano dovunque un patrimonio alimentare ereditato dalle generazioni passate, una fantastica ricchezza biologica e culturale che merita conoscere e sperimentare con umiltà e buon senso, senza improvvisazione. Ma anche un modo gioioso per entrare in contatto con saperi antichi e lontani, storia e storie: radici che si intrecciano tra la terra e la tavola, i simboli, i miti e i riti.
Ritorno alle radici
Tempo di lettura: 4 minuti
0votes