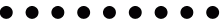Come ci ha insegnato la Scuola degli Annales di Marc Bloch e Lucien Febvre, la storia, quella vera, non è fatta tanto di politica e guerre, di trattati e teste coronate ma di società e lavoro, di vita quotidiana e gente comune. Così l’evoluzione della tavola e del costume alimentare non si può raccontare partendo dai ricettari storici, scritti dai cuochi dei nobili signori e destinati ai loro ricchi padroni. A dir la verità, nella sua opera “L’arte di ben cucinare e instruire i men periti in questa lodevole professione” (1662), il cuoco dei Gonzaga, messere Bartolomeo Stefani, include un’appendice dedicata al “vitto ordinario per otto persone”. Si tratta pur sempre di ricette che hanno però come ingrediente principale la carne, alimento costoso e precluso alla maggioranza del popolo-minuto, confermando così che il ricettario è destinato, bontà sua, anche ai cuochi di nobili non proprio facoltosi o dell’emergente classe dei ricchi borghesi. Dimentichiamoci per un attimo le Cene fin-de-siècle al Ritz di Parigi o quelle della Prima Classe del Titanic o del Rex. Lasciamo perdere i fasti epicurei della cena di Trimalcione, delle tavole cardinalizie del Concilio di Trento e dei banchetti rinascimentali dello Scappi e di Messisbugo. Scordiamoci anche delle pompose liste delle vivande dei ristoranti del primo Novecento e fingiamo di non aver mai letto i menù di certa ristorazione creativo-modernista che declina i piatti su tre righe con abuso di maiuscole (visto ieri: Raviolo di Kamut con ripieno di Animelle d’Agnello al Madera e Foie-Gras su vellutata di Sedano di Verona, râpée di Barbaforte, Noce Pecan e perle di Melograno Parfianka…). Ciò che resta è quasi sempre una cucina del buonsenso, comprensibile e rassicurante, una non-gastronomia senza fronzoli e orpelli, radicata nella terra e nel cuore di chi la fa e la consuma. Per secoli le classi sociali più povere hanno scritto la propria storia alimentare non sulla carta ma sulla polvere delle madie e sul nerofumo dei caminetti. Fino all’ultimo dopoguerra una famiglia di contadini poteva contare su due o tre ingredienti messi al fuoco in una sola pentola, un solo pezzo di pane scuro e una sola vivanda in un solo piatto. Spesso erano zuppe di verdure o polente fumanti accompagnate da un morso di formaggio o, per chi poteva permetterseli, da un boccone di aringa o baccalà. Rare le carni, rigorosamente festive, perlopiù porcine e salate, talvolta di cortile ma sempre bandite i venerdì e in quaresima. Mio nonno, contadino e pastore, classe 1889, fino all’età di dodici anni aveva mangiato sempre in un’unica ciotola di terracotta condivisa col padre sulla porta dell’ovile; ebbe davanti per la prima volta un vero piatto (scheggiato ma tondo e bianco) in canonica, quando fece la comunione. Ancora nel 1975, il buon vecchio si rifiutava di cambiare piatto tra una pietanza e l’altra: lo puliva dai resti del primo con una meticolosa “scarpetta”, pronto per il secondo. Oggi, la stragrande maggioranza delle persone che si definiscono “civilizzate”, rifiutano l’idea di mangiare pietanze diverse nella stessa stoviglia, più per convenzione sociale che per ragioni igieniche. Fino all’epoca della Rivoluzione Francese, gli invitati ad un banchetto gentilizio si servivano a piacimento da grandi vassoi già disposti sulla tavola o nelle sue vicinanze, più o meno come succede nei moderni buffet in cui la gente gira con lo sguardo vacuo e il piatto in mano chiedendosi cosa ci sia mai dentro le fiamminghe e i rechaud. Fu solo agli inizi dell’Ottocento che il principe russo Kourakin, ambasciatore dello zar a Parigi, riconobbe ad ogni portata il diritto di reclamare la propria dignità con una specifica sequenza (antipasto, primo, secondo, contorno e dessert), affidata al servizio di camerieri e valletti che porgevano ad ogni commensale i vari piatti prestabiliti e allestiti in cucina. Alcuni ristoranti parigini, tra cui quello dei fratelli Very (primi a fornire ai propri clienti il menù (carte des mets) nel 1790) adottarono la forma del “seul-plat” per rispondere alle richieste di una clientela più frettolosa e meno abbiente di quella agiata e gourmand che affollava regolarmente le loro sale. I seul-plats di Very, del Billard en Bois e del Café Procope mettevano su un’unica stoviglia una scodella di zuppa, una piccola porzione di carne o di pesce, dei legumi, una fettina di formaggio e del pane.
Come ci ha insegnato la Scuola degli Annales di Marc Bloch e Lucien Febvre, la storia, quella vera, non è fatta tanto di politica e guerre, di trattati e teste coronate ma di società e lavoro, di vita quotidiana e gente comune. Così l’evoluzione della tavola e del costume alimentare non si può raccontare partendo dai ricettari storici, scritti dai cuochi dei nobili signori e destinati ai loro ricchi padroni. A dir la verità, nella sua opera “L’arte di ben cucinare e instruire i men periti in questa lodevole professione” (1662), il cuoco dei Gonzaga, messere Bartolomeo Stefani, include un’appendice dedicata al “vitto ordinario per otto persone”. Si tratta pur sempre di ricette che hanno però come ingrediente principale la carne, alimento costoso e precluso alla maggioranza del popolo-minuto, confermando così che il ricettario è destinato, bontà sua, anche ai cuochi di nobili non proprio facoltosi o dell’emergente classe dei ricchi borghesi. Dimentichiamoci per un attimo le Cene fin-de-siècle al Ritz di Parigi o quelle della Prima Classe del Titanic o del Rex. Lasciamo perdere i fasti epicurei della cena di Trimalcione, delle tavole cardinalizie del Concilio di Trento e dei banchetti rinascimentali dello Scappi e di Messisbugo. Scordiamoci anche delle pompose liste delle vivande dei ristoranti del primo Novecento e fingiamo di non aver mai letto i menù di certa ristorazione creativo-modernista che declina i piatti su tre righe con abuso di maiuscole (visto ieri: Raviolo di Kamut con ripieno di Animelle d’Agnello al Madera e Foie-Gras su vellutata di Sedano di Verona, râpée di Barbaforte, Noce Pecan e perle di Melograno Parfianka…). Ciò che resta è quasi sempre una cucina del buonsenso, comprensibile e rassicurante, una non-gastronomia senza fronzoli e orpelli, radicata nella terra e nel cuore di chi la fa e la consuma. Per secoli le classi sociali più povere hanno scritto la propria storia alimentare non sulla carta ma sulla polvere delle madie e sul nerofumo dei caminetti. Fino all’ultimo dopoguerra una famiglia di contadini poteva contare su due o tre ingredienti messi al fuoco in una sola pentola, un solo pezzo di pane scuro e una sola vivanda in un solo piatto. Spesso erano zuppe di verdure o polente fumanti accompagnate da un morso di formaggio o, per chi poteva permetterseli, da un boccone di aringa o baccalà. Rare le carni, rigorosamente festive, perlopiù porcine e salate, talvolta di cortile ma sempre bandite i venerdì e in quaresima. Mio nonno, contadino e pastore, classe 1889, fino all’età di dodici anni aveva mangiato sempre in un’unica ciotola di terracotta condivisa col padre sulla porta dell’ovile; ebbe davanti per la prima volta un vero piatto (scheggiato ma tondo e bianco) in canonica, quando fece la comunione. Ancora nel 1975, il buon vecchio si rifiutava di cambiare piatto tra una pietanza e l’altra: lo puliva dai resti del primo con una meticolosa “scarpetta”, pronto per il secondo. Oggi, la stragrande maggioranza delle persone che si definiscono “civilizzate”, rifiutano l’idea di mangiare pietanze diverse nella stessa stoviglia, più per convenzione sociale che per ragioni igieniche. Fino all’epoca della Rivoluzione Francese, gli invitati ad un banchetto gentilizio si servivano a piacimento da grandi vassoi già disposti sulla tavola o nelle sue vicinanze, più o meno come succede nei moderni buffet in cui la gente gira con lo sguardo vacuo e il piatto in mano chiedendosi cosa ci sia mai dentro le fiamminghe e i rechaud. Fu solo agli inizi dell’Ottocento che il principe russo Kourakin, ambasciatore dello zar a Parigi, riconobbe ad ogni portata il diritto di reclamare la propria dignità con una specifica sequenza (antipasto, primo, secondo, contorno e dessert), affidata al servizio di camerieri e valletti che porgevano ad ogni commensale i vari piatti prestabiliti e allestiti in cucina. Alcuni ristoranti parigini, tra cui quello dei fratelli Very (primi a fornire ai propri clienti il menù (carte des mets) nel 1790) adottarono la forma del “seul-plat” per rispondere alle richieste di una clientela più frettolosa e meno abbiente di quella agiata e gourmand che affollava regolarmente le loro sale. I seul-plats di Very, del Billard en Bois e del Café Procope mettevano su un’unica stoviglia una scodella di zuppa, una piccola porzione di carne o di pesce, dei legumi, una fettina di formaggio e del pane.
Si può dunque affermare che il piatto-unico, più di due secoli fa, cessò di essere prerogativa alimentare proletaria e senza pretese ed entrò a pieno titolo nella ristorazione borghese. A gettare nuovamente discredito sul valore sociale del piatto-unico contribuì Adolf Hitler nel 1933, pochi mesi dopo essersi instaurato come Cancelliere, quando lanciò la campagna dell’Eintopfsonntag (appunto la “Domenica del piatto unico”) che obbligava le famiglie tedesche a mettere in tavola ogni domenica un solo piatto per commensale. Nel 1935 una nota della Cancelleria del Reich proclamava: “Proprio come i cristiani ricchi di fede si uniscono nel santo sacramento della Comunione, nel servizio del loro Signore Iddio, così anche la Germania Nazionalsocialista celebra il suo pasto sacrificale come voto solenne alla comunità di un Popolo indistruttibile”. L’anno successivo, in piena Guerra Civile spagnola, Francisco Franco adottò il modello nazista con l’istituzione del “Día del plato único” che imponeva alle famiglie – ricorrendo ancora una volta al senso religioso cristiano – di ridurre a una sola portata il pranzo e la cena di “ogni venerdì di Nostro Signore”. Per quanto riguardava hotel e ristoranti, ai clienti, obbligati a consumare solo il plato ùnico, si metteva in conto il prezzo del menù completo, così che la differenza venisse devoluta al “Fondo de Protección Benéfico Social”. La legge rimase in vigore fino al 1942. Emarginato dalla ristorazione italiana negli anni del miracolo economico e relegato perloppiù alle tavole-calde, alle mense collettive e alle caserme, il piatto-unico ha mantenuto una sua timida collocazione nelle colazioni di lavoro e nei pranzi leggeri e veloci. Negli anni ’90 tornarono di moda i grandi piatti da buffet divisi in tre o quattro settori da riempire al self-service o al brunch. Poi venne l’epoca delle cosiddette “insalatone”, in cui qualche infido oste infilava tra l’oscuro fogliame, brandelli di mediocre tonno, cubetti di formaggi laqualunque, fagioli in scatola, mais transgenico, pomodorini insapori e indegni sottaceti: l’apoteosi del pianto-unico. Oggi grazie al cielo non è più così e devo riconoscere che sempre più chef propongono piatti-unici creativi, di alto valore gastronomico e notevole equilibrio nutrizionale, in cui i sapori locali si uniscono spesso a citazioni di cultura anglosassone e di elementi orientali. Eppure, l’idea di sedermi al ristorante col pranzo costretto in un’unica stoviglia non mi entusiasma. Soprattutto perché non riesco a rinunciare all’affaccendarsi dei camerieri attorno alla mia postazione-di-piacere, all’andirivieni tintinnante e sommesso di stoviglie, posate e bicchieri. E soprattutto al sorriso quasi complice del maître che mi porge con garbo il menù e la carta dei vini.
Disavventure postume del “piatto unico”
Tempo di lettura: 4 minuti
0votes