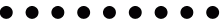Il ciliegio appartiene alla numerosa famiglia delle Rosaceae e al genere Prunus che oltre alla prugna e alla ciliegia comprende il biancospino, il melo, il pero, il pesco, il mandorlo e l’albicocco. I più antichi nòccioli di ciliegia sono stati rinvenuti, carbonizzati, nella grotta paleolitica di Gilvaran (valle di Khorramabad, Iran occidentale) e datati a 45mila anni fa. In Europa nòccioli di Prunus avium (ciliegio dolce o “degli uccelli”) e Prunus cerasum (ciliegio acido, marasco o amarena) sono documentati in numerosi siti europei – Svizzera, Francia, Italia, Ungheria, Inghilterra, Austria – abitati tra il Neolitico e l’Età del Bronzo (6000÷3000 a.C.) e non si esclude che i frutti siano stati anche pressati per estrarne il succo da far fermentare. Nell’Antica Grecia il keràsos era sacro ad Afrodite, dea della bellezza e dell’amore, ma per trovarne la prima menzione letteraria bisogna attendere il V sec. a.C., quando lo storico greco Erodoto nella sua “Historia” lo chiama “albero del Ponto”, attribuendolo a quella regione dell’Anatolia nord-orientale dove la selezione delle piante con i frutti migliori e la loro coltivazione potrebbe essere iniziata nel X secolo a.C. se non prima. Nel IV secolo a.C. il filosofo e botanico Teofrasto – allievo e successore di Aristotele – descrisse così il ciliegio: “Il keràsos è un albero di carattere particolare e di grande crescita; raggiunge anche un’altezza di 24 cubiti. La sua foglia è simile a quella della nespola, ma è dura e più larga; la sua corteccia è come quella del tiglio, il fiore è bianco, simile alla pera e alla nespola, composto da piccoli fiori cerosi. Il frutto è rosso… di dimensioni come una fava e il suo nocciolo è tenero”. Si legge nel “Deipnosofisti” di Ateneo di Naucrati che nel III sec. a.C. il medico greco Diphilos di Siphnos, nel suo trattato “Sulla dieta” definì le ciliegie “sane, succose, ma offrono poco nutrimento; sono particolarmente salutari se consumate crude. Le varietà rosse di Mileto sono superiori, essendo diuretiche”. Secondo Plinio il Vecchio le prime piante di ciliegio furono portate a Roma dal console Lucullo di ritorno dalla guerra contro Mitridate re del Ponto (circa 65 a.C.). Il nome latino cerasum deriverebbe appunto dalla città pontica di Cerasunte sul Mar Nero. Nel Medioevo gli alberi di ciliegio e di amarene abbellivano orti monastici e giardini nobiliari ma le ciliegie vendute al mercato erano quelle raccolte nelle campagne. L’alto contenuto di potassio valse loro la reputazione di diuretico, raccomandato anche dai medici che nel XIII secolo composero il “Regimen Sanitatis Salernitanum”: “Otterrai grandi benefici mangiando ciliegie / la cui polpa depura, da tono e il sangue rende buono. / E non gettar via il nocciolo che giova al mal della pietra”. All’epoca di Dante e Petrarca le tavole dei banchetti nuziali venivano letteralmente cosparse di ciliegie, metafora di bellezza, grazia e felicità, contrapposto alla mela associata al peccato e all’inganno. A metà ‘400 Bartolomeo Sacchi annotò nel suo “De honesta voluptate e valitudine” che essendo quell’albero il primo a fiorire e maturare in primavera, le ciliegie fresche dovevano essere servite nei banchetti come “apritivo” per lo stomaco. Di ugual parere era il medico Michele Savonarola che nel suo “Libreto de tutte le cose che se manzano” (1515) afferma che la ciliegia dolce, tenerina o durona, “se vole manzare nanti pasto” poiché stimola l’appetito e la sua acquosità la rende presto digeribile. Tuttavia, molti medici dell’epoca avvertivano che essendo la natura della ciliegia “fredda et humida” questa era dannosa per lo stomaco se non cotta o immersa nel vino. A crudo si raccomandava il consumo delle varietà acidule – marasche, amarene e visciole – più dissetanti; lo conferma Giovanni Sercambi nelle sue “Croniche” (1423) riportando che all’inizio di un banchetto “per rifrescamento li servidori apportonno di belle cerage agre e perfettissimi [vini] moscatelli”. Pietanze in cui le ciliegie dolci, fresche o secche, venivano cotte, sono frequenti nei libri di cucina rinascimentali. Si legge nel quattrocentesco. “Anonimo padovano” la ricetta di una minestra eseguita con ciliegie secche lessate in brodo di capponi con zucchero e profumo di sandalo. Mastro Martino da Como nel quasi coevo “Libro de Arte Coquinaria” descrive un savore di ciliegie fresche snocciolate, pestate col pane, stemperate con agresto o aceto e fatte bollire per mezz’ora con zenzero, cannella e altre spezie. Martino proponeva anche una torta ex merendis realizzata con una sfoglia grassa farcita di ciliegie pestate, petali di rosa, formaggio fresco, uova, cannella, zenzero, pepe e zucchero, da completare al momento del servizio con uno sciroppo dolce di acqua rosata. Sempre negli stessi anni, Benedetto Reguardati, medico di Francesco Sforza, istruiva i suoi lettori alla preparazione di una salsa di ciliegie “da conservare infino al verno”: se ne spreme il succo, lo si addensa al sole e lo si chiude in un vaso di vetro; all’occorrenza si stempera con aceto o agresto e se ne ricava un “savore” capace di eccitare l’appetito. Non può mancare una citazione alla millenaria ammirazione dei giapponesi per il ciliegio – metafora di educazione e buone maniere – e i suoi frutti, allegoria di virtù, clemenza e onestà. Ogni famiglia nipponica tradizionalista celebra l’hanami, cioè la millenaria festa dei ciliegi (sakura), sul monte Yoshino, avvolto in primavera da centomila alberi in fioritura. Lo stupore e l’ammirazione dei nipponici si condensa in questi due haiku (poesie in sole 17 sillabe) di autori sei-settecenteschi:
Il ciliegio appartiene alla numerosa famiglia delle Rosaceae e al genere Prunus che oltre alla prugna e alla ciliegia comprende il biancospino, il melo, il pero, il pesco, il mandorlo e l’albicocco. I più antichi nòccioli di ciliegia sono stati rinvenuti, carbonizzati, nella grotta paleolitica di Gilvaran (valle di Khorramabad, Iran occidentale) e datati a 45mila anni fa. In Europa nòccioli di Prunus avium (ciliegio dolce o “degli uccelli”) e Prunus cerasum (ciliegio acido, marasco o amarena) sono documentati in numerosi siti europei – Svizzera, Francia, Italia, Ungheria, Inghilterra, Austria – abitati tra il Neolitico e l’Età del Bronzo (6000÷3000 a.C.) e non si esclude che i frutti siano stati anche pressati per estrarne il succo da far fermentare. Nell’Antica Grecia il keràsos era sacro ad Afrodite, dea della bellezza e dell’amore, ma per trovarne la prima menzione letteraria bisogna attendere il V sec. a.C., quando lo storico greco Erodoto nella sua “Historia” lo chiama “albero del Ponto”, attribuendolo a quella regione dell’Anatolia nord-orientale dove la selezione delle piante con i frutti migliori e la loro coltivazione potrebbe essere iniziata nel X secolo a.C. se non prima. Nel IV secolo a.C. il filosofo e botanico Teofrasto – allievo e successore di Aristotele – descrisse così il ciliegio: “Il keràsos è un albero di carattere particolare e di grande crescita; raggiunge anche un’altezza di 24 cubiti. La sua foglia è simile a quella della nespola, ma è dura e più larga; la sua corteccia è come quella del tiglio, il fiore è bianco, simile alla pera e alla nespola, composto da piccoli fiori cerosi. Il frutto è rosso… di dimensioni come una fava e il suo nocciolo è tenero”. Si legge nel “Deipnosofisti” di Ateneo di Naucrati che nel III sec. a.C. il medico greco Diphilos di Siphnos, nel suo trattato “Sulla dieta” definì le ciliegie “sane, succose, ma offrono poco nutrimento; sono particolarmente salutari se consumate crude. Le varietà rosse di Mileto sono superiori, essendo diuretiche”. Secondo Plinio il Vecchio le prime piante di ciliegio furono portate a Roma dal console Lucullo di ritorno dalla guerra contro Mitridate re del Ponto (circa 65 a.C.). Il nome latino cerasum deriverebbe appunto dalla città pontica di Cerasunte sul Mar Nero. Nel Medioevo gli alberi di ciliegio e di amarene abbellivano orti monastici e giardini nobiliari ma le ciliegie vendute al mercato erano quelle raccolte nelle campagne. L’alto contenuto di potassio valse loro la reputazione di diuretico, raccomandato anche dai medici che nel XIII secolo composero il “Regimen Sanitatis Salernitanum”: “Otterrai grandi benefici mangiando ciliegie / la cui polpa depura, da tono e il sangue rende buono. / E non gettar via il nocciolo che giova al mal della pietra”. All’epoca di Dante e Petrarca le tavole dei banchetti nuziali venivano letteralmente cosparse di ciliegie, metafora di bellezza, grazia e felicità, contrapposto alla mela associata al peccato e all’inganno. A metà ‘400 Bartolomeo Sacchi annotò nel suo “De honesta voluptate e valitudine” che essendo quell’albero il primo a fiorire e maturare in primavera, le ciliegie fresche dovevano essere servite nei banchetti come “apritivo” per lo stomaco. Di ugual parere era il medico Michele Savonarola che nel suo “Libreto de tutte le cose che se manzano” (1515) afferma che la ciliegia dolce, tenerina o durona, “se vole manzare nanti pasto” poiché stimola l’appetito e la sua acquosità la rende presto digeribile. Tuttavia, molti medici dell’epoca avvertivano che essendo la natura della ciliegia “fredda et humida” questa era dannosa per lo stomaco se non cotta o immersa nel vino. A crudo si raccomandava il consumo delle varietà acidule – marasche, amarene e visciole – più dissetanti; lo conferma Giovanni Sercambi nelle sue “Croniche” (1423) riportando che all’inizio di un banchetto “per rifrescamento li servidori apportonno di belle cerage agre e perfettissimi [vini] moscatelli”. Pietanze in cui le ciliegie dolci, fresche o secche, venivano cotte, sono frequenti nei libri di cucina rinascimentali. Si legge nel quattrocentesco. “Anonimo padovano” la ricetta di una minestra eseguita con ciliegie secche lessate in brodo di capponi con zucchero e profumo di sandalo. Mastro Martino da Como nel quasi coevo “Libro de Arte Coquinaria” descrive un savore di ciliegie fresche snocciolate, pestate col pane, stemperate con agresto o aceto e fatte bollire per mezz’ora con zenzero, cannella e altre spezie. Martino proponeva anche una torta ex merendis realizzata con una sfoglia grassa farcita di ciliegie pestate, petali di rosa, formaggio fresco, uova, cannella, zenzero, pepe e zucchero, da completare al momento del servizio con uno sciroppo dolce di acqua rosata. Sempre negli stessi anni, Benedetto Reguardati, medico di Francesco Sforza, istruiva i suoi lettori alla preparazione di una salsa di ciliegie “da conservare infino al verno”: se ne spreme il succo, lo si addensa al sole e lo si chiude in un vaso di vetro; all’occorrenza si stempera con aceto o agresto e se ne ricava un “savore” capace di eccitare l’appetito. Non può mancare una citazione alla millenaria ammirazione dei giapponesi per il ciliegio – metafora di educazione e buone maniere – e i suoi frutti, allegoria di virtù, clemenza e onestà. Ogni famiglia nipponica tradizionalista celebra l’hanami, cioè la millenaria festa dei ciliegi (sakura), sul monte Yoshino, avvolto in primavera da centomila alberi in fioritura. Lo stupore e l’ammirazione dei nipponici si condensa in questi due haiku (poesie in sole 17 sillabe) di autori sei-settecenteschi:
“Oh, guarda! e null’altro da proferire, dinanzi ai ciliegi in fiore del monte Yoshino”. (Yasuhara Teishitsu)
“Cadono i fiori di ciliegio sugli specchi d’acqua della risaia: stelle, al chiarore di una notte senza luna”. (Yosa Buson)