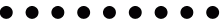Gli antichi chiamavano agrumi (“acer” = agro in latino) gli ortaggi dal sapore agro, come l’aglio e le cipolle. Con lo stesso nome, dal medioevo, si indicano le piante del genere Citrus e i loro prodotti, quasi tutti originari della Cina e del Giappone dove la loro coltivazione ha una storia millenaria. Arance e mandarini di Sicilia, mandaranci in Puglia, limoni di Procida, cedri di Calabria: una galassia di soli e lune trionfanti sui banchi dei mercati, raggianti nei cesti della frutta in luminoso contrasto con i colori del mondo, smorzati dall’inverno. Piante sempreverdi anche di alto valore ornamentale, sono da sempre abituali elementi decorativi di molti giardini storici o, dove il clima non ne consente lo sviluppo en plein air, di apposite serre con ampie vetrate, chiamate Limonaie od Orangeries. La frutta in genere fornisce all’organismo poche calorie. Ci si dimentica spesso, però, che gli agrumi hanno un “indice di appetibilità” piuttosto elevato (è quindi normale e piacevole mangiarne fino a saziarsi) ma anche un “indice di sazietà” decisamente basso (prima di avvertire il senso di “pieno” allo stomaco se ne saranno mangiati parecchi). Questo è il motivo per cui molte diete “fai da te”, costruite sulla falsa idea che chi mangia molta frutta (specialmente l’uva) dimagrisce facilmente, sono destinate al fallimento. Sei arance hanno lo stesso contenuto calorico di un piatto di spaghetti, tre mandarini “pesano” sul nostro bilancio calorico come due belle fette di pane, e una dolce banana equivale più o meno a una porzione di crostata di frutta. Insomma, un pranzo tutto a base di frutta rischia di avvicinarsi pericolosamente alle 1000 Kcal. senza darci il piacere gustativo e la gratificazione che ci dà un pranzo tradizionale con minore apporto calorico (70 grammi di pasta condita, 80 grammi di carne ai ferri, un piatto di insalata e una porzione di pane). A questo va aggiunto che la frutta è avara di grassi (le nostre riserve di energia) e di proteine (i “mattoni” con cui ricostruiamo l’organismo ogni giorno), quindi chi segue una dieta a base di frutta deve supplire a precise carenze nutrizionali integrando una dieta squilibrata e poco saziante (ma già calorica…) con aggiunte di carne, riso o pasta, senza dimenticare i grassi, olio d’oliva su tutti. Non vorrei apparire come uno intenzionato a sminuire l’importanza degli agrumi nella dieta dell’uomo di buon senso e di buon gusto. A casa mia le cassette di arance regnano sovrane da ottobre a marzo, clementine e mandarini si sprecano, e d’inverno sui termosifoni di ogni stanza troneggiano mucchietti di bucce di agrumi che profumano l’aria meglio di quei costosi evaporatori di deodoranti di sintesi che non avrei coraggio di dimenticare nemmeno in una porcilaia (ne esiste anche un modello elettronico, che grazie a un sensore diffonde l’orrendo intruglio quando ci si passa davanti. Lo spot televisivo lo definisce “intelligente”. Ma non chi lo compra). In quanto ai limoni – che Eugenio Montale definiva “le trombe d’oro della solarità” – ne metto sempre due in bella vista nel cesto di frutta sul tavolo da pranzo. Sono convinto che portino fortuna, che stimolino il buonumore. E non sono il solo. In tutto il mondo arabo al limone è assegnato il compito di tenere lontani gli spiriti maligni dalla casa e dalle persone. In Kurdistan i cimiteri sono circondati da limoneti i cui frutti non vengono mai raccolti, e in India le bucce dei limone vengono buttate sulle pire durante le cremazioni dei defunti. Si tratta di credenze e rituali che trovano la loro ragion d’essere proprio nelle valenze terapeutiche del succo di limone (note ai cinesi già seimila anni fa) che hanno risolto per millenni gli esiti emorragici delle ferite di guerra, hanno guarito casi di avvelenamento e hanno fatto fronte al flagello delle dissenterie collettive. Spesso rinvenuti nelle tombe egiziane con datteri e fichi, i limoni erano anche ingrediente fondamentale nelle imbalsamazioni dei defunti. Presso i greci antichi era comune piantare alberi di limone vicino agli ulivi per scongiurare gli attacchi di parassiti. Meno attratti dal giallo agrume erano i latini che lo consideravano un frutto esotico e raro. Plinio lo magnifica come antidoto per i veleni e l’imperatore Nerone, ossessionato dalla paura di essere avvelenato, ne faceva un uso smodato. Nel 1951 a Pompei, nella “Casa del Frutteto” venne scoperta la prima testimonianza pittorica di una pianta di limone, il che porta a pensare che all’epoca dell’eruzione del Vesuvio (79 d.C.) la coltivazione dell’agrume in Italia fosse già una realtà, seppure circoscritta a curiosità botanico-ornamentale. Curiosamente, pur essendo certo che la coltivazione dei limoni iniziò in Sicilia verso l’anno Mille grazie agli Arabi, la prima vera piantagione commerciale fu realizzata a Genova a metà del ‘400. In quell’epoca infatti si era appena scoperto che l’uso regolare del limone a bordo delle navi preveniva e guariva lo scorbuto, malattia endemica degli equipaggi costretti a mangiare per lungo tempo solo cibi conservati e poveri di vitamina C. E fu proprio un genovese che intraprese il più lungo e fortunato viaggio ad occidente, mantenendo in salute i suoi marinai fino alla meta. La scoperta dell’America fu dovuta forse a un errore di calcolo, forse a un colpo di fortuna. Ma certamente fu resa possibile anche da qualche cassa di limoni gelosamente custodita nel buio delle stive delle tre caravelle. Tra varietà estive (i verdelli), autunnali (bastardi) e invernali (marzani, maiolini e bianchetti) compro solo varietà italiane come lo Sfusato, il Monachello, il Santa Teresa, il Femminello, lo Zagara Bianca, il Siracusano, il Lunario o il Continella. Scelgo sempre quelli non trattati in superficie con cera e poltiglia antifungo, e preferisco esemplari provvisti di foglie che considero un segnale di freschezza. Con i miei limoni quotidiani cancello il mucido (freschino) delle uova per le frittate e i dolci, ne grattugio la scorza gialla in sughi e salse, la aggiungo ai cartocci di pesce al forno, nelle marinate di carne, uso il succo per togliere il sapore di selvatico alle carni scure e alla selvaggina, lo spremo nelle macedonie di frutta fresca per non farle ossidare, idem su carciofi, cardi, carote. Il suo succo appena cavato dà nerbo alle verdure cotte, condisce i radicchi crudi e le misticanze, nobilita la bresaola più insipida, cuoce senza fuoco le carni e i pesci… Solo due cose evito come la peste: spremere succo di limone sulle fritture e sulla carne alla brace. Sono atti vandalici che offendono sia il cibo che il lavoro dell’oste, che denunciano la pochezza del gusto di chi le attua e l’ignoranza di chi le propone. Il succo di limone non serve a coprire l’imperfezione di gusto di un gambero di sei giorni o di una costata di chianina mal frollata. La consuetudine di servire le pietanze di pesce o di carne assieme ai limoni risale al medioevo, quando l’uso delle mani per prendere i cibi dal piatto comune era una regola e la pulizia delle dita era più necessità igienica che forma di rispetto. Passare uno spicchio di limone tra le dita come “disinfettante” (tra l’altro inutile…) prima di prendere le vivande dal piatto comune, divenne prassi all’epoca delle grandi pestilenze, così come pulire col limone il bordo di ogni bicchiere o le posate. Spesso poi la fetta di limone strizzata veniva lasciata nel bicchiere dell’acqua (l’ho visto fare anche in quello del vino!) a scopo (ripeto, inutilmente) “disinfettante”. Qualche secolo fa aveva forse un senso. Non oggi, perdìo! Quindi diffidate del cuciniere che vi manda un piatto di calamari alla piastra – che già solo per il fatto di uscire dalle mani di un professionista dovrebbe essere “perfetto” nell’equilibrio – guarnito con spicchi di limone, messi lì a suggerirvi di aggiustarne la modestia organolettica. E se proprio non potete fare a meno di qualche goccia di limone, chiedete che il frutto vi sia portato intero, ben lavato, su un taglierino di legno. È l’unico modo per essere certi di avere a che fare con spicchi appena tagliati e non manipolati da venti mani, sporche di farina, prezzemolo o… peggio. Concludo allontanandomi solo qualche passo dal fornello per ficcare il naso nel lavandino. Quanti dei cinquemilioni di quintali di limoni che si raccolgono in Italia finiscono nei flaconi di detersivi per piatti (o per pavimenti), negli shampoo e nei dentifrici che si dichiarano “al limone”? Pochi, pochissimi graziaddìo. Perché quasi sempre il potere sgrassante e il profumo di pulito e sano che il limone ci regala è dovuto a un idrocarburo (un terpene) derivato dal riciclo dei… vecchi pneumatici.
Gli antichi chiamavano agrumi (“acer” = agro in latino) gli ortaggi dal sapore agro, come l’aglio e le cipolle. Con lo stesso nome, dal medioevo, si indicano le piante del genere Citrus e i loro prodotti, quasi tutti originari della Cina e del Giappone dove la loro coltivazione ha una storia millenaria. Arance e mandarini di Sicilia, mandaranci in Puglia, limoni di Procida, cedri di Calabria: una galassia di soli e lune trionfanti sui banchi dei mercati, raggianti nei cesti della frutta in luminoso contrasto con i colori del mondo, smorzati dall’inverno. Piante sempreverdi anche di alto valore ornamentale, sono da sempre abituali elementi decorativi di molti giardini storici o, dove il clima non ne consente lo sviluppo en plein air, di apposite serre con ampie vetrate, chiamate Limonaie od Orangeries. La frutta in genere fornisce all’organismo poche calorie. Ci si dimentica spesso, però, che gli agrumi hanno un “indice di appetibilità” piuttosto elevato (è quindi normale e piacevole mangiarne fino a saziarsi) ma anche un “indice di sazietà” decisamente basso (prima di avvertire il senso di “pieno” allo stomaco se ne saranno mangiati parecchi). Questo è il motivo per cui molte diete “fai da te”, costruite sulla falsa idea che chi mangia molta frutta (specialmente l’uva) dimagrisce facilmente, sono destinate al fallimento. Sei arance hanno lo stesso contenuto calorico di un piatto di spaghetti, tre mandarini “pesano” sul nostro bilancio calorico come due belle fette di pane, e una dolce banana equivale più o meno a una porzione di crostata di frutta. Insomma, un pranzo tutto a base di frutta rischia di avvicinarsi pericolosamente alle 1000 Kcal. senza darci il piacere gustativo e la gratificazione che ci dà un pranzo tradizionale con minore apporto calorico (70 grammi di pasta condita, 80 grammi di carne ai ferri, un piatto di insalata e una porzione di pane). A questo va aggiunto che la frutta è avara di grassi (le nostre riserve di energia) e di proteine (i “mattoni” con cui ricostruiamo l’organismo ogni giorno), quindi chi segue una dieta a base di frutta deve supplire a precise carenze nutrizionali integrando una dieta squilibrata e poco saziante (ma già calorica…) con aggiunte di carne, riso o pasta, senza dimenticare i grassi, olio d’oliva su tutti. Non vorrei apparire come uno intenzionato a sminuire l’importanza degli agrumi nella dieta dell’uomo di buon senso e di buon gusto. A casa mia le cassette di arance regnano sovrane da ottobre a marzo, clementine e mandarini si sprecano, e d’inverno sui termosifoni di ogni stanza troneggiano mucchietti di bucce di agrumi che profumano l’aria meglio di quei costosi evaporatori di deodoranti di sintesi che non avrei coraggio di dimenticare nemmeno in una porcilaia (ne esiste anche un modello elettronico, che grazie a un sensore diffonde l’orrendo intruglio quando ci si passa davanti. Lo spot televisivo lo definisce “intelligente”. Ma non chi lo compra). In quanto ai limoni – che Eugenio Montale definiva “le trombe d’oro della solarità” – ne metto sempre due in bella vista nel cesto di frutta sul tavolo da pranzo. Sono convinto che portino fortuna, che stimolino il buonumore. E non sono il solo. In tutto il mondo arabo al limone è assegnato il compito di tenere lontani gli spiriti maligni dalla casa e dalle persone. In Kurdistan i cimiteri sono circondati da limoneti i cui frutti non vengono mai raccolti, e in India le bucce dei limone vengono buttate sulle pire durante le cremazioni dei defunti. Si tratta di credenze e rituali che trovano la loro ragion d’essere proprio nelle valenze terapeutiche del succo di limone (note ai cinesi già seimila anni fa) che hanno risolto per millenni gli esiti emorragici delle ferite di guerra, hanno guarito casi di avvelenamento e hanno fatto fronte al flagello delle dissenterie collettive. Spesso rinvenuti nelle tombe egiziane con datteri e fichi, i limoni erano anche ingrediente fondamentale nelle imbalsamazioni dei defunti. Presso i greci antichi era comune piantare alberi di limone vicino agli ulivi per scongiurare gli attacchi di parassiti. Meno attratti dal giallo agrume erano i latini che lo consideravano un frutto esotico e raro. Plinio lo magnifica come antidoto per i veleni e l’imperatore Nerone, ossessionato dalla paura di essere avvelenato, ne faceva un uso smodato. Nel 1951 a Pompei, nella “Casa del Frutteto” venne scoperta la prima testimonianza pittorica di una pianta di limone, il che porta a pensare che all’epoca dell’eruzione del Vesuvio (79 d.C.) la coltivazione dell’agrume in Italia fosse già una realtà, seppure circoscritta a curiosità botanico-ornamentale. Curiosamente, pur essendo certo che la coltivazione dei limoni iniziò in Sicilia verso l’anno Mille grazie agli Arabi, la prima vera piantagione commerciale fu realizzata a Genova a metà del ‘400. In quell’epoca infatti si era appena scoperto che l’uso regolare del limone a bordo delle navi preveniva e guariva lo scorbuto, malattia endemica degli equipaggi costretti a mangiare per lungo tempo solo cibi conservati e poveri di vitamina C. E fu proprio un genovese che intraprese il più lungo e fortunato viaggio ad occidente, mantenendo in salute i suoi marinai fino alla meta. La scoperta dell’America fu dovuta forse a un errore di calcolo, forse a un colpo di fortuna. Ma certamente fu resa possibile anche da qualche cassa di limoni gelosamente custodita nel buio delle stive delle tre caravelle. Tra varietà estive (i verdelli), autunnali (bastardi) e invernali (marzani, maiolini e bianchetti) compro solo varietà italiane come lo Sfusato, il Monachello, il Santa Teresa, il Femminello, lo Zagara Bianca, il Siracusano, il Lunario o il Continella. Scelgo sempre quelli non trattati in superficie con cera e poltiglia antifungo, e preferisco esemplari provvisti di foglie che considero un segnale di freschezza. Con i miei limoni quotidiani cancello il mucido (freschino) delle uova per le frittate e i dolci, ne grattugio la scorza gialla in sughi e salse, la aggiungo ai cartocci di pesce al forno, nelle marinate di carne, uso il succo per togliere il sapore di selvatico alle carni scure e alla selvaggina, lo spremo nelle macedonie di frutta fresca per non farle ossidare, idem su carciofi, cardi, carote. Il suo succo appena cavato dà nerbo alle verdure cotte, condisce i radicchi crudi e le misticanze, nobilita la bresaola più insipida, cuoce senza fuoco le carni e i pesci… Solo due cose evito come la peste: spremere succo di limone sulle fritture e sulla carne alla brace. Sono atti vandalici che offendono sia il cibo che il lavoro dell’oste, che denunciano la pochezza del gusto di chi le attua e l’ignoranza di chi le propone. Il succo di limone non serve a coprire l’imperfezione di gusto di un gambero di sei giorni o di una costata di chianina mal frollata. La consuetudine di servire le pietanze di pesce o di carne assieme ai limoni risale al medioevo, quando l’uso delle mani per prendere i cibi dal piatto comune era una regola e la pulizia delle dita era più necessità igienica che forma di rispetto. Passare uno spicchio di limone tra le dita come “disinfettante” (tra l’altro inutile…) prima di prendere le vivande dal piatto comune, divenne prassi all’epoca delle grandi pestilenze, così come pulire col limone il bordo di ogni bicchiere o le posate. Spesso poi la fetta di limone strizzata veniva lasciata nel bicchiere dell’acqua (l’ho visto fare anche in quello del vino!) a scopo (ripeto, inutilmente) “disinfettante”. Qualche secolo fa aveva forse un senso. Non oggi, perdìo! Quindi diffidate del cuciniere che vi manda un piatto di calamari alla piastra – che già solo per il fatto di uscire dalle mani di un professionista dovrebbe essere “perfetto” nell’equilibrio – guarnito con spicchi di limone, messi lì a suggerirvi di aggiustarne la modestia organolettica. E se proprio non potete fare a meno di qualche goccia di limone, chiedete che il frutto vi sia portato intero, ben lavato, su un taglierino di legno. È l’unico modo per essere certi di avere a che fare con spicchi appena tagliati e non manipolati da venti mani, sporche di farina, prezzemolo o… peggio. Concludo allontanandomi solo qualche passo dal fornello per ficcare il naso nel lavandino. Quanti dei cinquemilioni di quintali di limoni che si raccolgono in Italia finiscono nei flaconi di detersivi per piatti (o per pavimenti), negli shampoo e nei dentifrici che si dichiarano “al limone”? Pochi, pochissimi graziaddìo. Perché quasi sempre il potere sgrassante e il profumo di pulito e sano che il limone ci regala è dovuto a un idrocarburo (un terpene) derivato dal riciclo dei… vecchi pneumatici.
Agrumi, colori, profumi, sapori
Tempo di lettura: 5 minuti
0votes